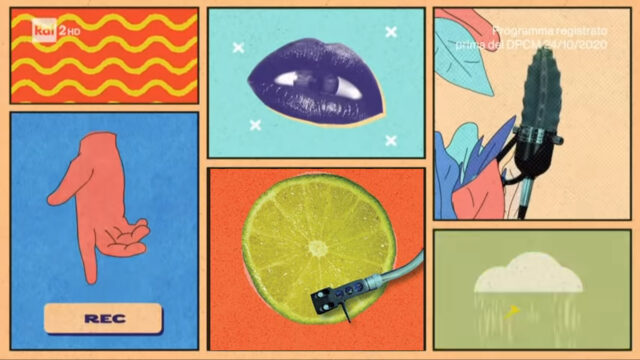Prima di essere invitata a un rave, sono andata a ballare per due mesi, più volte a settimana, a serate dello stesso collettivo. I ragazzi e le ragazze (si riferiscono al loro gruppo come la family) hanno cominciato a riconoscermi e hanno imparato il mio nome. Abbiamo iniziato a sentirci su Instagram – si dicevano entusiasti che ci fossimo visti quella sera, mi chiedevano se ci sarei stata la volta seguente. Dopo qualche tempo ho cominciato a ricevere, in modo asciutto e un po’ criptico, dei link per scaricare app di messaggistica anonima. Il rave era in un bunker degli spazi della metropolitana pubblica di Torino, la notte di domenica, e l’aveva organizzato un gruppo francese.
Nonostante il conflitto apparente con la storia e addirittura l’impianto urbanistico, rigidamente sabaudo, la regia Torino è considerata dagli aficionados della club culture la sorella minore di Berlino. Anche restando in superficie non è un caso che sia l’unica città italiana a vantare come attive sul territorio – o perlomeno presenti – organizzazioni e iniziative come la Art&Club Commission (omologa di quella berlinese) e Club Futuro, «uno slancio collettivo per costruire il futuro della notte e dei club, partendo dalle pratiche virtuose di tutto il mondo».
Come polo di fama internazionale, Torino ospita serate perlopiù dedicate ai rami della musica elettronica – spesso a opera di collettivi affermati, come le organizzazioni GENAU e SHOUT! – e festival di spessore come il Kappa Futurfestival (primo festival 100% diurno in Italia, menzionato dal The New York Times nel 2016 e che, nello stesso anno, ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea) e il Club To Club, attivo dal 2002.

Ma accanto alle organizzazioni “mainstream”, Torino vanta anche la presenza solida di un humus sotterraneo (underground nel senso letterale, e non per definizione) di amanti del genere: perlopiù collettivi musicali – e artisti autonomi che occasionalmente vi si accostano – composti da dj, performers, greeters e staff di vario genere. La maggior parte di questi collettivi non è fedele a un’unica sede – non possiede, cioè, un club in cui è “resident” – ma si sposta a seconda delle esigenze, organizzando sia feste legali che clandestine. Nei tempi in cui la club culture è stata costretta al sonno (quello recente delle quarantene da Covid-19) Torino vibrava comunque di serate comunicate e organizzate attraverso chat di gruppo ad accesso controllato. Serate non autorizzate si susseguivano, un paio di volte a settimana, in discoteche chiuse nelle zone periferiche o in aree abbandonate – come un teatro gigantesco nel sottosuolo del centro di Torino, o case private messe a disposizione dagli inquilini.
Ho parlato con G, che con un certo orgoglio risponde a vari dei ruoli sopracitati – dj, organizzatore di feste clandestine e non, abitante di una casa a Torino Nord spesso adibita a location da rave – e gli ho chiesto perché, secondo lui, tutto questo succede a Torino.
Mi racconta che la cultura del clubbing – sorella più chiacchierata di quella del raving – affonda le sue radici nella definizione di underground. Club ultrafamosi di Berlino come il Berghain e il Kitkat (fondato da un regista porno austriaco con l’apposito scopo di un locale dove fosse possibile fare sesso in pubblico) nascevano come locali della comunità LGBTQ+ o comunque luoghi in cui l’esperienza musicale fosse calata in un’atmosfera di massimo agio, soprattutto per tutti quei comportamenti disapprovati o vietati altrove, all’insegna di una libertà (forse meglio liberazione) esente dal giudizio.
Underground sta per sotterraneo, clandestino, contro il sistema. E, secondo G, la storia industriale di Torino ha covato, negli anni, un bacino molto fertile per una categoria di svago che come definizione primaria avesse l’equivalente di “contro il sistema”. Una popolazione giovanile per gran parte di origine operaia o comunque a basso reddito e una serie di spazi industriali abbandonati negli anni hanno prodotto un terreno molto ricco per la germogliazione di un certo tipo di serate.

È interessante quindi che, anche ora che a Torino la società è cambiata e la nightlife dei locali regala un’ampia offerta, resista un’alternativa di serate sotterranee e quindi, per definizione, illegali. Storicamente, la matrice più autentica del clubbing è strettamente legata a luoghi segreti, di difficile raggiungimento, serate a cui si accede solo tramite invito diretto. I rave urbani del 2022 funzionano ancora così: questo perché, dice G, ai rave acceda una clientela (loro non dicono clientela – loro dicono gente, persone) selezionata.
Una festa in una location non autorizzata fa sì che i partecipanti debbano seguire un percorso ostico, e quindi selettivo. Per ricevere il link (che viene inviato spontaneamente, e di solito non si chiede) che permette di accedere al gruppo bisogna conoscere qualcuno degli organizzatori, possedere un account su app di messaggistica anonime (Signal o Telegram) e fare richiesta per entrare. A quel punto qualcuno degli interni contatta il richiedente in privato e domanda da chi ha ricevuto il link; se la risposta è soddisfacente, si entra nel gruppo.
I gruppi sono bloccati: solo gli admin (quindi, gli organizzatori) possono mandare messaggi, e la location non viene svelata fino a festa iniziata, ma viene solitamente comunicato un punto d’incontro da cui ci si muove verso lo spazio adibito – precedentemente oggetto di un sopralluogo da parte dell’organizzazione.
Questo processo è molto più complicato di trovare sui social una serata che piaccia anche agli amici e fare la fila per entrare all’ingresso del locale. E, sebbene significhi per l’organizzazione meno partecipazione e quindi un guadagno ridotto, per i ravers è bene che rimanga così. La partecipazione è ristretta ma più selezionata, scremati i poco pratici del genere: meno affluenza degli occasionali che vivono la serata come pretesto per approcci facili, meno giovanissimi inesperti che potrebbero creare problemi.
Anche perché, e sembra quasi paradossale, ai rave non si creano problemi. Una dimensione generalmente (e a ragione) associata all’uso smodato di droghe “da festa” (principalmente MD e rami dell’ecstasy, pasticche, ketamina, cocaina) si accompagna a un uso consapevole delle stesse, limitato solo dall’obbligo di non rovinare l’esperienza altrui. Non è raro che a questo genere di serate (anche quelle legali) sia presente un banchetto di Neutravel (progetto di riduzione del danno e limitazione dei rischi nei contesti del divertimento notturno giovanile) attrezzato con il necessario per sniffare, gelatine alla frutta e chewingum per le contrazioni mandibolari, ma anche un’area di decompressione e chill-out per dialogare con gli operatori.
All’assistenza sanitaria e all’autocontrollo personale – le cui sviste esistono, certo, ma più rare di quanto si potrebbe pensare – si accompagna un senso di comunità solido ed efficace del gruppo organizzatore: lo staff stesso si impegna nel restare vigile durante la serata per evitare episodi spiacevoli, si premura di girare di tanto in tanto offrendo bottigliette d’acqua (pulita) affinché chi balla resti idratato.
L’attenzione alla sicurezza si applica – molto bene, come non ho visto fare altrove – anche alle molestie sessuali, di solito frequenti negli ambienti della vita notturna. L’atmosfera di questo tipo di serate, libera e non giudicante nell’ambito dell’espressione fisica – non è raro vedere semi-nudità e scambi di effusioni, anche tra più persone – resiste per via di un’attenzione al consenso che purtroppo è da considerare atipica.
G mi racconta di un episodio in cui un ragazzo ubriaco si è mostrato molesto, infastidendo un paio di ragazze con palpeggiamenti non richiesti: nell’arco di mezz’ora è stato identificato e riconosciuto dai ragazzi dell’organizzazione, e alle serate successive si è visto impedito l’ingresso. Da frequentate della nightlife italiana non ho visto succedere niente del genere, in nessun altro tipo di evento notturno.
È affascinante quindi come in un ambiente spesso stigmatizzato per le droghe, l’alcol e la libertà sregolata in generale quest’ultima appaia in realtà molto più sicura che altrove. La sregolatezza non ha regole a cui obbedire ma si attiene ad alcuni principi, pochi ma solidi, e condivisi. È una libertà che risente di un controllo a opera della comunità, non arbitrario e forzato (non sempre ci sono buttafuori), ma estremamente efficace.
In uno spazio in cui la comunione con gli altri è elemento fondamentale dell’esperienza stessa è lampante (molto più che altrove) come un’incrinatura dell’atmosfera leda sé e l’altro, quando si è legati a doppio senso. Si potrebbe dire un modello – imperfetto, ovviamente – di anarchia funzionante, un falansterio tempio della musica elettronica.
Questo equilibrio di dinamiche non è possibile da ricreare in locali dove, per forza di cose, l’obiettivo finale è l’incasso. È difficile che in una discoteca venga impedito di bere a un cliente già chiaramente ubriaco; l’uso di droghe viene tassativamente ignorato – il che ovviamente non vuol dire sia assente, anzi, è rarissimo che qualcuno venga allontanato per una molestia “minore”.
I rave cittadini o le serate underground non sono situazioni esenti da rischi: ma non sono ambienti che si mostrano come tali, e dunque i partecipanti ne prendono coscienza e si muovono di conseguenza. Se tutti partecipano dei rischi (anche solo essere presenti e non necessariamente fare uso di alcol o sostanze) tutti ne sono a conoscenza, e si muovono per evitarne o arginarne eventuali esiti spiacevoli.
Per scrivere questo pezzo sono partita da due grandi domande: perché Torino è la sorella italiana del clubbing berlinese, e se è possibile legalizzare tutte le sue feste notturne. Le risposte che mi sono data, forse prevedibilmente, si intersecano e dipendono da una lunga lista di fattori, che è tassativo valutare in senso amorale.
Torino ha covato la cultura del raving perché la sua ben nutrita classe operaia desiderava uno spazio clandestino dove divertirsi al riparo dalla realtà e dal giudizio. Nelle feste underground questo ancora accade, e portarle alla luce significherebbe perderne la peculiarità fondamentale – la dedizione, la cura di chi mantiene il segreto.
Autore
Teresa Fraioli
Autrice
Sono nata a Roma, dove ho imparato bene l’inglese e male a guidare, e poi mi sono trasferita a Torino per studiare Contemporary Humanities. Lavoro come editor perché a volte mi trovo meglio con le voci degli altri. Se non l’avesse già fatto Waller-Bridge, la mia ambizione nella vita sarebbe scrivere Fleabag.