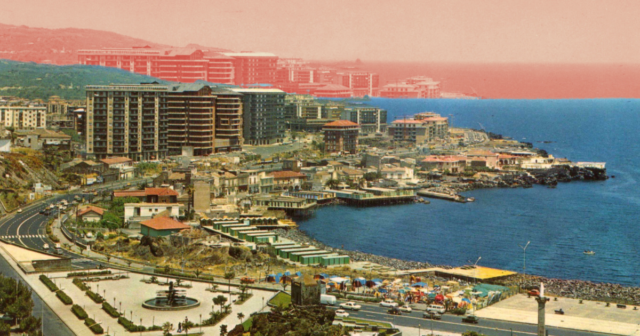Tra metodo e prassi
L’esperienza del collettivo ex-Gkn ha ricordato che cosa sia la storia e la concretezza delle azioni, in un mondo, quello del neoliberismo, che ci schiaccia quotidianamente, e che nega violentemente entrambe le cose. Non si tratta di una questione filosofica, ma di una mobilitazione politica che ha prodotto fino ad oggi risultati concreti, giuridici, che stanno costruendo un metodo nuovo per il lavoro e le relazioni industriali.
Più precisamente, il collettivo dei lavoratori ex-Gkn, insieme ad una rete sociale fatta di ricercatori, cittadini e militanti solidali, ha nel tempo costruito un modello di democrazia economica per realizzare la re-industrializzazione della fabbrica, abbandonata alla speculazione finanziaria prima, e immobiliare poi. Lo ha fatto con l’approvazione di una legge regionale che istituisce la possibilità di creare consorzi pubblici di sviluppo industriale, enti che possono essere costituiti e partecipati da una serie di soggetti, tra cui la Regione, i Comuni, ma anche le università, i centri di ricerca, società cooperative, le camere di commercio, dell’artigianato, dell’industria e dell’agricoltura. Tali consorzi potranno occuparsi di coadiuvare i processi di reindustrializzazione del territorio, con particolare supporto alle cooperative di lavoro e alla sostenibilità ecologica, oltre che culturale, della produzione.
Ricostruiamo brevemente questa storia, per capire di più come siamo arrivati ad oggi, e per spiegare meglio in cosa consista questo modello di democrazia economica, che ha il grande pregio di valere non solo in questo caso, ma in generale, avendo creato una salda unione tra metodo e prassi.
Quattro anni di lotta
Il 9 luglio del 2021 nello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio (ex Fiat fino agli anni Novanta) che produceva semiassi per automobili e veicoli commerciali – in gran parte per commissioni di Stellantis – vennero licenziati 422 dipendenti con una mail. Quei licenziamenti saranno dichiarati illegittimi a distanza di poco più di due mesi, dal Tribunale di Firenze, per violazione degli obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali. Da quel 9 luglio gli operai presidiano la fabbrica: sono passati più di quattro anni e, ancora ogni giorno, attaccano in turni di 8 ore per tutelare non solo il proprio posto di lavoro, ma la capacità produttiva e la tenuta occupazionale di un intero territorio, sempre più colpito da un costante ripetersi di chiusure e delocalizzazioni delle produzioni verso paesi con livelli salariali più bassi e scarsa o quasi inesistente garanzia dei diritti dei lavoratori.
I circa 120 lavoratori rimasti sono stati licenziati – dopo l’annullamento, ancora da parte del Tribunale di Firenze, di un’altra procedura di licenziamento avviata nell’ottobre del 2023 – con effetto dal primo aprile scorso (2024). Gli operai sono rimasti comunque a presidio dello stabilimento, nonostante un anno e mezzo di stipendi non pagati, le minacce di sgombero della proprietà e, più recentemente, per complesse procedure fallimentari, anche da parte dell’autorità giudiziaria. L’assetto proprietario è oggi diviso fra tre società, tra cui QF – proprietaria effettiva dell’azienda e sottoposta attualmente a liquidazione giudiziale – e due società da essa controllate, a cui è stato trasferito lo stabilimento.
Tutte e tre le società sono riconducibili a Francesco Borgomeo, già advisor di Melrose, il fondo finanziario che era proprietario, tra gli altri, anche dello stabilimento Gkn fiorentino. Una volta che il fondo britannico, in ossequio al motto da adottato per descrivere la propria strategia aziendale: “buy, improve, sell” (compra, migliora, vendi), aveva deciso per la chiusura dello stabilimento italiano, trasferì a dicembre del 2021 la proprietà dell’azienda allo stesso Borgomeo, peraltro per una cifra mai resa nota.
La riconversione ecologica dal basso: un piano industriale scritto dagli operai
Oggi, a distanza di 4 anni, i timori che l’imprenditore romano, non certo noto per i suoi successi industriali, dovesse svolgere la mera funzione di traghettatore verso il perfezionamento della delocalizzazione risultano più che fondati. Il suo piano industriale più volte promesso – e sintetizzato anche nel ribattezzamento della società, “Quattro F“ ossia “Fiducia nel Futuro della Fabbrica di Firenze” – non è mai arrivato, e ad oggi, gli unici piani industriali sul campo sono quelli elaborati dai lavoratori, supportati da ingegneri, giuristi ed economisti solidali alla lotta. Se il primo, che prevedeva un forte investimento per la creazione con altre società di un polo pubblico della mobilità sostenibile, in cui lo stabilimento fiorentino avrebbe prodotto semiassi per autobus a idrogeno, è stato abbandonato per l’assoluta indisponibilità del governo.
Il piano in procinto di essere attuato – sviluppato a partire dal 2023 e che rioccuperebbe oltre 100 operai, continuando ad applicare le condizioni del contratto collettivo dei metalmeccanici di cui godevano prima del licenziamento – comprende sia la produzione di pannelli fotovoltaici che il recupero di quelli esausti, nonché una linea di produzione di cargo bike (ancora poco diffuse in Italia) per una mobilità collettiva e una logistica di prossimità più sostenibili. Un piano, quindi, che sintetizza un’idea di riconversione ecologica della produzione, immaginata e progettata dal basso dagli stessi operai. Allo stesso tempo – per la sua capacità di esprimere un esempio perfetto, seppur di scala assai ridotta, di just transition – ha rappresentato anche un elemento di avvicinamento e convergenza tra il Collettivo di fabbrica e il movimento ecologista italiano, in particolare Fridays For Future Italia, con cui già nel marzo 2022 venne indetta una manifestazione congiunta a cui parteciparono oltre trentamila persone.
A guidare la re-industrializzazione sarebbe la cooperativa fondata dai lavoratori, GFF (Gkn For Future), forte di un capitale raccolto attraverso campagne di azionariato popolare che hanno superato 1,5 milioni di euro di sottoscrizioni, a cui si aggiungono le linee di finanziamento bancario. Resta però il nodo dello stabilimento, inaccessibile alla cooperativa per i suoi costi e dimensioni.
L’occasione del consorzio pubblico per la re-industrializzazione
È qui che entra in gioco la legge regionale sui consorzi di sviluppo industriale. Tale legge – approvata nel dicembre dello scorso anno dal Parlamento della Regione Toscana dopo un’intensa mobilitazione fatta di cortei e anche di uno sciopero della fame di tre operai – ha introdotto nell’ordinamento regionale una cornice normativa per costituire consorzi pubblici che favoriscano e accompagnino i processi di re-industrializzazione. Uno strumento normativo, quindi, prodotto da una lotta operaia, ma che è a disposizione di tutte le future crisi industriali – come era già successo con la legge antidelocalizzazioni approvata nel dicembre 2021 dopo una più ambiziosa proposta avanzata dal Collettivo di fabbrica – e che può rappresentare un’ispirazione anche per altre Regioni, si pensi al Piemonte con il distretto automobilistico di Torino ex Fiat, colpite da processi dei-ndustrializzazione e dalle sfide poste dalla transizione ecologica.
“Ciò che oggi è necessario sfatare è la convinzione sedimentata per cui le politiche pubbliche non possano, o addirittura non debbano, influire sui processi economici all’interno dei confini nazionali e regionali. In questi anni abbiamo assistito inermi a una de-responsabilizzazione costante della politica istituzionale su crisi industriali, delocalizzazioni e fenomeni di speculazione sugli stabilimenti produttivi all’interno del territorio nazionale” – hanno scritto Matteo Amatori e Benedetta Celati, tra i ricercatori coinvolti nella stesura della proposta di legge – “i numerosi e generosi aiuti economici concessi alla proprietà delle imprese nell’ultimo trentennio sono stati privi di una qualsiasi progettualità: non deve stupire, quindi, che non abbiano saputo incidere sull’occupazione, sulle condizioni (retributive, contrattuali, organizzative) del lavoro, sulla sua utilità sociale e sulla compatibilità ecologica dei suoi prodotti. Soprattutto, in questi anni è mancata una visione complessiva e d’insieme in termini di pianificazione capace di anticipare o almeno di reagire efficacemente alle crisi industriali”.
Dei consorzi industriali che in base a tale legge possono essere costituiti, la loro funzione principale, soprattutto nel caso di Gkn, è rendere economicamente sostenibile la re-industrializzazione del sito, acquisendo lo stabilimento e mettendolo, nelle varie forme giuridiche disponibili, a disposizione della cooperativa dei lavoratori (ma anche di altri soggetti privati interessati) per l’attuazione del suo piano industriale. In questo modo, verrebbero anche arginati i progetti di speculazione immobiliare che ovviamente insistono sul sito industriale e che da tempo sono denunciati dal Collettivo di fabbrica – si tratta infatti di 80 mila metri quadri a poca distanza dall’A1, l’autostrada che collega Milano a Napoli, passando per Firenze e Roma, che fanno gola soprattutto al settore della logistica. Lo strumento per garantire questo risultato, anche contro la volontà della società proprietaria dello stabilimento, è riconosciuto dalla legge nella forma dell’esproprio (art. 4): i consorzi possono infatti dichiarare di “pubblica utilità” gli impianti da realizzare sul territorio e a tal fine proporre agli enti competenti provvedimenti espropriativi (in questo caso il Comune di Campi Bisenzio). Sul fatto che tali poteri possano poi essere concretamente esercitati non paiono esserci dubbi. “Con la nuova legge regionale è il momento di agire, noi siamo pronti anche ad espropriare” – aveva dichiarato già all’indomani dell’approvazione della legge Lorenzo Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, il comune in cui si trova lo stabilimento.
Il consorzio tanto atteso è stato formalmente costituito il 28 luglio scorso. A farne parte sono la Regione Toscana (con il 70% di quote di partecipazione), la Città Metropolitana di Firenze (10%) e i Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio – dove ha sede lo stabilimento – e Calenzano (complessivamente con una partecipazione del 20%) , per un capitale iniziale di 315.000 euro. “In un mondo di fondi finanziari e rendita immobiliare, il consorzio industriale pubblico permette alle istituzioni locali di intervenire sulle aree ex industriali, proteggerle, rilanciarle con una visione di politica industriale pubblica” – ha commentato il Collettivo di fabbrica, che però richiama le istituzioni ad accelerare i tempi, dato il logoramento del tessuto operaio, adesso ancora beneficiario dell’indennità di disoccupazione a seguito dei licenziamenti.
Soprattutto, il timore è che il consorzio stesso e l’opportunità di finanziarlo e sostenerlo siano lasciati alla costante dilatazione e allungamento dei tempi di cui questa stessa vertenza, da parte delle istituzioni regionali e non solo, ha già subito un pesante logoramento: “Sembrava impossibile che il consorzio nascesse” – ha ribadito infatti il Collettivo – “ora sembra impossibile che agisca in tempo. Noi siamo qua per rendere possibile ciò che sembra impossibile. Fino a che ce ne sarà”.
E ora?
Oggi, siamo arrivati ad un punto fondamentale di questa storia: il corteo del 18 ottobre a Firenze e l’assemblea del 19 ottobre in fabbrica saranno un ulteriore slancio verso un progetto concreto e non idealistico, come ormai appare chiaro. Questo momento di mobilitazione, l’ennesimo, permette di comprendere un altro aspetto, non meno importante, di tutta la vicenda: la sua intersezionalità.
Una parola che viene spesso strumentalmente presentata come astratta, ma che invece significa che tutte le lotte sono connesse: non è un caso che una delle principali parole d’ordine del Collettivo di questi anni sia stata la “convergenza”, e non è un caso che l’idea di fabbrica socialmente integrata sia l’obiettivo finale da perseguire.
La corsa al riarmo, la mancata conversione ecologica e la necessità che questa parta dal basso, il crescente autoritarismo politico, l’economia del genocidio e il movimento di solidarietà per la Palestina e contro il genocidio, sono tutti elementi che il Collettivo di fabbrica ha articolato e connesso: sono l’altra faccia di una stessa medaglia, quella della finanza speculativa che genera delocalizzaizioni, estrae risorse e le reinveste per generare ulteriore profitto. Aver smascherato le connessioni di un disegno indubbiamente complesso e oscuro, che costituisce l’ossatura del capitalismo finanziario, è un grande merito di questa storia collettiva, che è di nessuno e quindi di tutti. Non è individualizzabile, e per questo può essere riutilizzata.
La fabbrica socialmente integrata è un’idea pragmatica di democrazia economica: unisce cogestione, pianificazione e socializzazione dell’economia, permettendo la creazione di un modello che mette al centro il lavoro, considerandolo il fondamento del nostro vivere comune. Quest’ultimo diventa quindi uno spazio di libertà e non una costrizione, quando è democratizzato.
Questa vertenza costituisce un argine contro il buio del momento che viviamo, generando un orizzonte, e continuerà a farlo al di là del suo esito temporaneo. Ma il piano di reindustrializzazione della ex-GKN, come ha scritto il collettivo pisano Exploit in un recente appello, “è anche un’alternativa alla dipendenza dal combustibile fossile, pretesto e obiettivo dei conflitti, una soluzione alla crisi produttiva e un passo avanti verso la democrazia energetica. Mettere a terra la transizione ecologica, dal basso, è oggi più che mai la nostra comune priorità”. “Per questo – continua il collettivo toscano – la lotta della ex-GKN è l’occasione di ricomporre sempre più lotte in aderenza al tutto di genocidio e riarmo. Riaprire la fabbrica significa riaprire un orizzonte di possibilità per disertare la guerra oltre il solo piano di movimento e per costruire l’alternativa tramite la transizione ecologica dal basso. La possibilità di vedere altre vertenze simili nei prossimi anni nel nostro Paese non può prescindere del tutto da questa vittoria. Per questo tutte e tutti noi ci dobbiamo assumere la responsabilità del 18 ottobre: della vittoria, così come dell’eventuale sconfitta di questa vertenza. Deve essere la convergenza politica e umana larghissima che in questi anni si è stretta attorno alla fabbrica di sogni a dare la spallata finale all’immobilismo delle istituzioni”. Tocca quindi a tutte e tutti noi, il 18 ottobre a Firenze, riaprire la nuova GKN.
Autori
Federico Mastroianni
Autore
Classe 2001, ma mi sento molto più vecchio. Studente di Giurisprudenza a Roma, aspirante giornalista (infatti mi piace molto scrivere), ma anche suonare la chitarra. E questo è quanto.