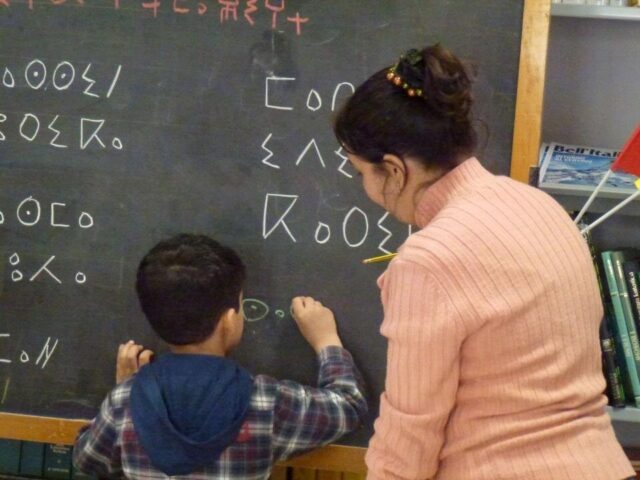Frantz Omar Fanon nasce in Martinica, nel cuore dell’ordine coloniale francese. Attraverso poesia, psichiatria, filosofia, teoria politica, esperienze di guerra e lotta di liberazione, ha lasciato fratture profonde nella psicologia del dominio occidentale. I suoi studi costruiscono una critica radicale che ha segnato i movimenti del Sud Globale, dall’Africa ai Caraibi, dall’Asia Occidentale fino all’America Latina.
Durante la sua breve vita pubblica due testi destinati a diventare il cuore degli studi decoloniali: Pelle nera, maschere bianche (1952), un’autopsia della violenza psicologica del colonialismo, e I dannati della terra (1961), il manifesto incendiario scritto mentre lavora come psichiatra e diplomatico della rivoluzione algerina. A questi si aggiungono le raccolte di saggi L’anno V della rivoluzione algerina (1959) e Per la rivoluzione africana (1964).
Arriva in Algeria nel 1953 e comincia a lavorare come psichiatra al manicomio di Blida-Joinville. L’esperienza diretta con la violenza coloniale lo porta ad essere uno dei più grandi teorici della rivoluzione anti-coloniale del Novecento. Passa dalla diagnosi della razzializzazione alla radiografia dell’intero sistema coloniale. Qui, Fanon scrive per riviste scientifiche e giornali clandestini, si unisce al Fronte di Liberazione nazionale algerino, diventa diplomatico per il governo provvisorio algerino in Ghana e viaggia per il continente africano partecipando a varie conferenze.
La sua scrittura circola tra studenti europei, militanti africani, intellettuali caraibici, fino al 1961, anno segnato dalla diagnosi fulminante di leucemia che lo porta ad abbandonare il suo lavoro: muore il 6 dicembre al National Institutes of Health negli Stati Uniti, a soli 36 anni.
Il suo primo libro, Pelle nera, maschere bianche (1952), scritto a 27 anni, è un’opera di frattura importante che crea un prima e un dopo negli studi decoloniali. Fanon mescola psicoanalisi, esistenzialismo, fenomenologia e le influenze della Négritude e del pensiero afroamericano di Richard Wright. Tenta di spiegare come nasce il razzismo anti-nero, come si infiltra nella coscienza e come deforma i rapporti tra bianchi e neri.
Dopo Pelle nera, maschere bianche il suo orizzonte si allarga, ampliando lo sguardo sull’intera architettura dell’oppressione coloniale. Pelle nera, maschere bianche nasceva dalla necessità di comprendere come un mondo strutturato contro le persone nere incida sul corpo e sulla psiche: in Algeria, Fanon capisce che quel meccanismo riguarda tutte le popolazioni colonizzate del Sud globale. È qui che la sua analisi diventa sistemica e che nasce il Fanon de I dannati della terra.
La pubblicazione de I dannati della terra nel 1961, è il momento in cui la sua riflessione sull’anticolonialismo diventa un manifesto globale, un detonatore teorico capace di influenzare rivoluzioni, guerriglie, movimenti culturali e immaginari politici di interi continenti. Il capitolo iniziale è composto dal testo introduttivo di Sartre, ed è proprio qui che Fanon mette sul tavolo la questione che attraversa tutta l’opera: la violenza. Per Fanon la violenza è una condizione storica ineludibile, è ciò da cui parte qualsiasi processo di liberazione, l’unica lingua che il colono comprende davvero e la sola che permette al colonizzato di riscrivere la propria posizione nel mondo.
George Ciccariello-Maher, in Decolonizing Dialectics, spiega come Fanon non stia esaltando la violenza in sé come mezzo punitivo o vendicativo, ma stia descrivendo un nuovo modo di pensare la rottura rivoluzionaria quando ogni altro linguaggio è inutile alla liberazione.
Fanon analizza tre “figure” della colonia in I dannati della terra: la prima è il lavoratore colonizzato che dipende dal colonizzatore per sopravvivere: dentro questa contraddizione c’è il potenziale rivoluzionario, ma anche una forma di cooptazione quotidiana difficile da scardinare. La seconda è l’intellettuale colonizzato, il personaggio più problematico. È l’intermediario culturale, quello che traduce la realtà dei colonizzati nel linguaggio dei colonizzatori. Vive in due mondi, e proprio per questo rischia continuamente di tradire quello da cui viene. Fanon gli riconosce una potenzialità enorme, ma solo se riesce a disertare davvero la posizione in cui il colonialismo l’ha incastrato.
La terza figura è il lumpenproletariat, ovvero le masse marginali come gli sfollati, i disoccupati, i contadini impoveriti e gli abitanti delle bidonville. Persone fuori dal sistema e proprio per questo la minaccia più pura per l’ordine coloniale. Non hanno niente da perdere e nessun legame materiale con la macchina coloniale. Fanon li considera il vero motore della rivoluzione: l’escluso totale che, proprio perché esterno, può rovesciare tutto.
La violenza, per Fanon, non è un dettaglio della lotta anticoloniale ma il punto di rottura, l’interruzione brusca che rivela tutto ciò che il sistema coloniale tenta disperatamente di occultare. Il colonialismo vive infatti nell’idea che il colonizzato sia intrinsecamente debole, inferiore, quasi naturalmente predisposto alla propria condizione di sottomissione. Quando il colonizzato spezza questo schema, costringe il colonizzatore a vedere, magari per la prima volta, la piena umanità di chi voleva ridurre a oggetto. Parallelamente, scuote il colonizzato, che scopre in quel gesto la propria possibilità, la propria capacità di diventare soggetto. Da qui nasce l’identità politica, culturale e collettiva, come processo necessario di disalienazione.
Il primo capitolo di I dannati della terra è proprio l’esplosione di questo potere trasformativo. Nei capitoli successivi Fanon, però, non si illude, evidenzia come il post-coloniale sia un terreno accidentato, pieno di insidie. Ma la decisione di spezzare l’ordine coloniale, è il punto da cui tutto può partire.
A più di sessant’anni dalla sua morte, colpisce sempre quanto l’eredità di Fanon superi di gran lunga la quantità – tutto sommato esigua – dei suoi scritti. In appena dieci anni di lavoro intellettuale, Fanon ha costruito un corpus minuscolo se confrontato con altri giganti del pensiero politico. Due libri monumentali, Pelle nera, maschere bianche e I dannati della terra, e due opere composte da saggi sparsi come A Dying Colonialism (1959) e Toward the African Revolution (1964).
I testi più brevi – interventi urgenti scritti tra una riunione clandestina e un reparto psichiatrico – restituiscono l’immagine di un pensatore in costante movimento. Fanon era immerso nella rivoluzione algerina, nella pratica medica, nel vortice geopolitico che stava ridisegnando il mondo. Non stupisce che dagli anni Sessanta in avanti i militanti latinoamericani lo leggessero per capire come nasce un soggetto rivoluzionario. In Africa e in Asia, il suo nome circolava nelle cellule clandestine quanto nelle aule universitarie. Nel mondo anglofono è diventato un punto fermo degli studi culturali.
La sua forza sta nella capacità di fondere analisi teorica e descrizione fenomenologica del corpo colonizzato. Nasce dal modo in cui Fanon guarda ai “dannati della terra”, come una presenza concreta, carnale. Persino il lumpen – il più marginale, il più scartato – contiene un’energia capace di ribaltare l’ordine coloniale. È questo sguardo, radicale e concreto, che ha reso Fanon una bussola per chi cerca giustizia nelle società modellate dal razzismo e dal colonialismo. Fanon ha saputo nominare la condizione coloniale con una precisione che non ha mai smesso di risuonare. Ha offerto strumenti a chi vive sulla propria pelle le architetture dell’oppressione. E ha mostrato che, anche nei luoghi più schiacciati dalla violenza, esiste una forza capace di riscrivere il mondo.
Chi oggi pensa alla liberazione – in Africa, in Palestina, nei Caraibi, nelle periferie occidentali – continua a dialogare con lui e ad ampliare il suo pensiero. Frantz Omar Fanon resta uno strumento vivo nelle lotte che continuano ancora ad oggi.