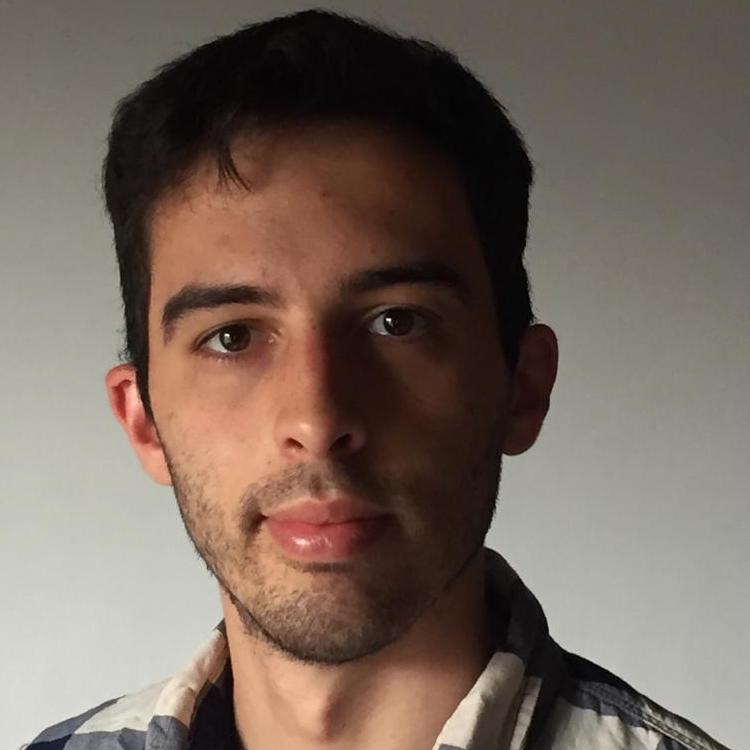«Se populista vuol dire ascoltare i bisogni delle persone, allora sì, sono populista!». Parole e musica di Giuseppe Conte 1.0, quello del governo gialloverde. Un personaggio che è difficile riconoscere oggi, quando dà la sua investitura ufficiale a Roberto Gualtieri. Dei compagni di viaggio del Conte I, Luigi Di Maio si è convertito sulla via di Damasco (in un’intervista del 25 febbraio, parlava del M5S come di una forza «moderata e liberale»), mentre Matteo Salvini è stato folgorato da Mario Draghi. Salvo poi pentirsi del gesto dopo il tracollo delle amministrative, con un partito che non sembra seguirlo più. Alessandro Di Battista pare pronto a riscendere in campo per ridare vigore a quel populismo («il fascismo è la finanza», ha dichiarato a Siena), ma forse qualcosa è cambiato rispetto a 4 anni fa, quando l’Italia sembrava essere pronta a essere “annessa” al blocco di Visegrad.
BoJo a pezzi
Tempi duri per i populisti di tutto il mondo da quando Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca e li ha (forse) privati di una guida. Prendiamo Boris Johnson: discendente indiretto di re e primi ministri, con un’istruzione di primo livello (su internet è ancora disponibile il suo dibattito Civiltà Greca vs Romana contro Mary Beard, una delle più grandi studiose di storia romana al mondo) e costretto a fingersi “uno del popolo”. Sulla campagna per la Brexit e sulla banalizzazione di temi in realtà molto complessi ha costruito la sua fortuna politica. Stessa attitudine, unita a una buona dose di puro cinismo, è stata utilizzata nella gestione della pandemia: non tanto nella prima ondata, quando della malattia si sapeva poco e niente, quanto più nella seconda, quando nella primavera e nell’estate scorsa ha ricominciato a intestardirsi sulla questione dell’immunità di gregge, contro ogni parere scientifico. De facto finendo per trasformare, così facendo, il Regno Unito in un’incubatrice di varianti.
Adesso, però, qualche nodo sta venendo al pettine: l’Hard Brexit che aveva proposto fa fatica a ingranare, il paese è diviso in due (le merci provenienti dall’Irlanda del Nord devono attraversare una dogana per entrare in Inghilterra), non c’è stato quel netto miglioramento delle condizioni di vita e dei fondi per la sanità pubblica e molte zone, senza i fondi europei, sono tornate ad essere economicamente depresse (citofonare al governo gallese per maggiori informazioni). A questo, si aggiunge un Paese incattivito, che pensava di liberare posti di lavoro cacciando la gente del Continente con una delle leggi più restrittive del mondo. E tra la lunga lista di streghe messe al bando, chiaramente, comparivamo anche noi italiani. Il viceministro Foster, l’estate scorsa, è stato chiarissimo su questo punto: chi non è in regola, anche se vive da tempo nel Regno Unito, dovrà fare le valigie. Altrimenti, il dipartimento anti-immigrazione saprà essere molto persuasivo sul tema. Risultato? Il paese fatica ogni giorno di più ad approvvigionarsi delle materie prime più elementari, ed è costretto a fornire permessi di lavoro temporanei (in forma di visti) a camionisti, braccianti agricoli e lavoratori non qualificati, di solito provenienti dall’Est Europa. Quel tipo di lavori che i britannici non vogliono fare, così come gli stranieri in regola con i requisiti della legge britannica sull’immigrazione: un contratto di lavoro di almeno 25.000 sterline l’anno (30.000€), un titolo di studio avanzato (tipo PhD), una conoscenza dell’inglese già buona oppure un lavoro in settori considerati “strategici” dalla Gran Bretagna. Il danno d’immagine per BoJo è evidente.
Il Parlamento britannico non ci va piano con il Primo Ministro nemmeno sulla gestione della pandemia: in un rapporto rilasciato il 12 ottobre, parla della gestione della prima parte della pandemia come di «uno dei peggiori fallimenti a livello di salute pubblica mai affrontati da parte del Regno Unito». I più stretti consiglieri sanitari di Johnson avrebbero preso troppo sottogamba l’epidemia, provocando così la morte di migliaia di britannici, che potevano essere salvati. Infatti, se solo si fosse intervenuti con misure severe la settimana prima del 23 marzo, osservando intelligentemente e responsabilmente la situazione in Italia, 40.000 vite probabilmente sarebbero state risparmiate. Ma il governo si è rifiutato fino all’ultimo, non volendo imporre una misura considerata “troppo impopolare”. Risultato? I morti di Covid in Gran Bretagna sono stati 150.000.
Un capitolo a parte lo meriterebbero gli Europei di calcio, una delle manifestazioni più (male) politicizzate degli ultimi anni: il Primo Ministro con la maglia dell’Inghilterra, il governo che insiste per aumentare la capienza negli stadi, le violenze contro i tifosi ospiti, i tantissimi episodi di dubbio gusto (mai condannati dal governo britannico, per altro). Ma, a prescindere da queste sottigliezze, all’indomani della manifestazione, l’Organizzazione Mondiale della Sanità già parlava di «disastro sanitario», rispetto ai contagi da Covid.

Come detto, i nodi vengono al pettine: in un Regno Unito in cui è diventato difficile persino fare un pieno e in cui gli scaffali dei supermercati sono spesso vuoti, la popolarità di BoJo è scesa al 34%, secondo i sondaggi di Yougov. Pensano, invece, che stia agendo male 6 britannici su 10. Ad aprile 2020, in piena pandemia, a giudicare il suo operato come “buono” c’era il 66% della popolazione britannica. Ci sono ancora tre anni per recuperare la popolarità perduta, ma questo mix di improvvisazione, paura di fare scelte impopolari e “annuncite” (dagli annunci-vincite trionfali sulla campagna vaccinale fatta solo con prime dosi a Euro2020) rischia di essere fatale a BoJo, se non dovesse cambiare rotta.
BolsOUT
La malagestione della pandemia rischia di essere fatale a un altro leader del populismo, con pulsioni molto più autoritarie di Boris Johnson. Stiamo parlando di Jair Bolsonaro.
Il presidente brasiliano era andato al potere nel 2016 presentandosi come l’argine autoritario alle ruberie del Partito Socialista guidato da Dilma Rousseff, finita in mezzo all’affare di tangenti di Petrobas. L’ex generale aveva allora proposto al suo paese maggior sicurezza, dopo decenni di “lassismo”, a suo dire. Si pensava che il Brasile non potesse eleggere un presidente evangelico (gli evangelici sono anche la base elettorale di Donald Trump e, addirittura, dei suoi simpatizzanti in Nigeria), misogino e omofobo. Invece, nel mentre, è riuscito anche a ottenere endorsement dal mondo sportivo, con Kakà, Rivaldo e Ronaldinho (curiosamente, tutti e tre transitati per il Milan di Berlusconi) che hanno fatto campagna per lui in prima persona. Infine, non bisogna dimenticare il sostegno della lobby agricola brasiliana, la vera responsabile della deforestazione in Brasile, a cui il presidente ha promesso l’allentamento dei (pochi) vincoli ambientali sulla Foresta Amazzonica.
E poi? E poi, due anni dopo la sua elezione, è arrivato il covid. A portare Bolsonaro al successo è stato anche un discreto impianto di produzione di fake news “alla Steve Bannon”. Uno schema che ha ripetuto anche durante la pandemia, quando ha continuato a non fidarsi dei pareri scientifici e a sventolare la sua cura miracolosa, la clorochina. Questo anche dopo che ben 4 ministri del suo governo, curati con la clorochina, avevano preso il covid-19. Solo nel febbraio 2021, a un anno dallo scoppio della pandemia, Bolsonaro ha ammesso che «forse è un placebo». Questo però solo dopo che il Presidente era riuscito a imporla come cura standard per i sintomi lievi del covid. La vaccinazione? È partita solo a metà gennaio, sebbene ora quasi un brasiliano su due sia vaccinato. A metà aprile, quando la campagna vaccinale stentava ancora a decollare, si era toccato il massimo dei morti a livello giornaliero, con più di 3000 vittime. A partire da maggio, però, il numero di morti è calato drasticamente, e oggi siamo sotto i 200 al giorno. Peccato che questi due anni d’indecisione abbiano portato il Brasile sopra la soglia dei 600.000 morti. Il tasso di morti pro capite è il settimo più alto al mondo. Quello di morti in assoluto è il secondo, dopo gli Stati Uniti. Paese, va ricordato, molto più anziano. Bolsonaro continua a non vaccinarsi e ha dichiarato di «essere stufo di rispondere a domande sul covid». Nel mentre, il paese scende in piazza per chiedere la sua destituzione.

Anche a livello di deforestazione, il Brasile inizia a essere un problema. Solo due anni fa il presidente inaugurava il “sovranismo ecologico”: «L’Amazzonia è patrimonio del Brasile, non dell’umanità. Se gli europei vogliono più foreste, le piantino nel loro continente». Oggi è molto più difficile per lui difendere questa posizione, anche perché alla Casa Bianca non c’è più il suo “alter ego” Donald Trump, ma Joe Biden. Malgrado questo, Bolsonaro non si arrende: ad aprile aveva proposto a Biden qualche miliardo per fargli schierare l’esercito al limitare della foresta amazzonica e bloccare la deforestazione. Un piano naufragato quasi subito. Nel mentre, la sua base elettorale di contadini non lo molla, ma deve fare i conti con le proteste degli indigeni e con una denuncia per crimini contro l’umanità all’Aia, per la deforestazione dell’Amazzonia. Che ha raggiunto il tasso più alto negli ultimi 10 anni.

E poi c’è lui, l’elefante di cui Bolsonaro non vuole parlare, ma che comincia a diventare un problema: Luiz Ignacio Lula da Silva. L’ex presidente voleva partecipare già alla tornata elettorale precedente, ma c’era un piccolo problema: era in prigione. Era entrato nel frullatore dei processi per corruzione che avevano colpito il Partito Socialista. Ad accusarlo, lo zelante magistrato Sergio Moro (nominato ministro della giustizia il giorno dopo l’entrata in carica di Bolsonaro) che era riuscito a condannarlo a 17 anni per corruzione. L’8 marzo è stata la stessa Corte Suprema ad annullare la condanna all’ex presidente, che ora è libero di ricandidarsi. Questo ha portato un conflitto fra la presidenza e la Corte Suprema: ad agosto ha chiesto la deposizione del giudice Alexandre Moraes, che investiga su eventuali finanziamenti da parte del presidente a gruppi d’ultradestra che hanno “avvelenato i pozzi” durante la campagna elettorale. A metà ottobre, inoltre, dovrà rispondere alle accuse del suo ex ministro Moro, che lo accusa di aver fatto pressioni sulla polizia federale per fare depistaggio sulle indagini in cui è coinvolto suo figlio.
Covid, deforestazione, problemi con la giustizia, un Lula possibile sfidante alle elezioni, proteste in tutto il paese per chiedere l’impeachment… sulla testa di Bolsonaro si sta addensando la tempesta perfetta. Secondo i sondaggi, è il primo presidente della storia brasiliana a non essere favorito per le elezioni a un anno dal voto: Lula viene dato intorno al 42-46%, mentre Bolsonaro è fra il 26 e il 31%. Sono solo sondaggi, ma sembra difficile al momento immaginare un trionfo dell’ex generale. Va detto che Lula anche ha dei tratti populisti molto marcati, sebbene sembri poi più equilibrato sui dossier ambiente e relazioni internazionali.
Visegrad perde i pezzi?
Il 9 ottobre, dopo l’assalto alla CGIL e con le polemiche su Forza Nuova, la sconfitta del premier centrista e populista Andrej Babiš è passata in secondo piano. Eppure, potrebbe essere stato un momento spartiacque per il populismo europeo perché è il secondo colpo assestato a quello che pareva il granitico Gruppo di Visegrad. Per chi non è pratico del tema, stiamo parlando di quattro paesi euroscettici (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria) in Europa Centrale, che si sono uniti in una sorta di “Lega” per bloccare ulteriori avanzamenti del progetto d’integrazione europea e d’ingerenza di Bruxelles nei loro affari interni. Il primo a sfilarsi era stato stato la Repubblica Slovacca, con il premier euroscettico Robert Fico sconfitto dalla sfidante progressista Zuzana Čaputova nel 2019.

La caduta di Babiš lascia Budapest e Varsavia abbastanza scoperte, in un momento in cui sono arrivate allo scontro frontale con l’UE, dal momento in cui Varsavia ha dichiarato la sua adesione all’Unione “incostituzionale”. Lo stesso Orban si era speso in prima persona per Babiš, nella città ceci di Ustì nad Labem: «Gli ungheresi sarebbero molto contenti di continuare ad avere un così bravo primo ministro». Babiš ha incentrato la sua carriera politica sulla lotta all’Unione europea, presentando Bruxelles come «lontana dagli interessi dei cechi» e ha chiesto «l’abolizione dell’inutile parlamento europeo». È il secondo uomo più ricco della Repubblica Ceca e ha cercato di usare la sua immagine di self-made man per guidare il Paese come se fosse un’azienda. Se vi suona familiare, non preoccupatevi. Non siete soli. Si è presentato con il suo partito ANO (Unione dei cittadini insoddisfatti) come il castigatore dei corrotti, ma il suo nome è uscito fuori nei leaks dei Pandora Papers. La vittoria della coalizione di centrodestra Spolu alle elezioni non è schiacciante, sia chiaro: i vari partiti contrari a Babiš controllano 108 seggi su 200. Ma abbastanza per far calare il sipario su un presidente considerato capriccioso, pronto a cambiare del tutto la rotta del suo paese in base ai sondaggi, che non ha mai preso una posizione chiara fra Mosca e Bruxelles. Nel mentre, però, Babiš “flirta” col partito Libertà e Democrazia Diretta, che propone (in un paese già di suo fortemente euroscettico) un referendum sulla “Czexit” come contropartita per entrare nel governo. Chi è fortemente pro-Cremlino è il presidente della Repubblica Miloš Zeman, ricoverato in terapia intensiva per una grave forma di diabete dal giorno dopo le elezioni. L’opinione pubblica punta il dito contro il suo stile di vita sregolato (fuma e beve tantissimo), ma una cosa è certa: senza l’investitura di Zeman, nessun nuovo governo può avere un’investitura. Perciò, sia Babiš che il suo competitor Petr Fiala, ex rettore dell’Università Masaryk di Brno, dovranno ancora aspettare.
Autore
Camillo Cantarano
Autore
Amo il data journalism, la politica internazionale e quella romana, la storia. Odio scrivere bio(s) e aspettare l'autobus. Collaboro saltuariamente con i giornali, ma mooolto saltuariamente