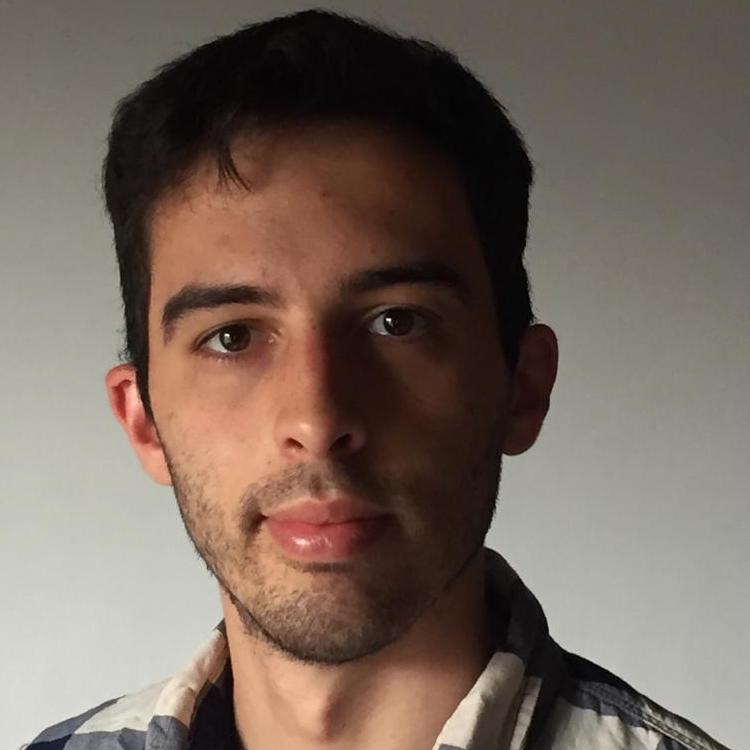L’Afghanistan è stato tanti paesi in uno, nel corso dei secoli. Per la generazione dei nostri nonni, era stato il cimitero delle ambizioni britanniche di bloccare l’espansionismo russo verso l’Asia Centrale con tre guerre cruentissime (1839-42; 1878-80; 1919), dichiarate per sostenere un proprio candidato per il governo a Kabul.
Per chi era un adolescente negli anni ’70, invece, Afghanistan significava “Hippie Trail”: turismo a basso costo, tante esperienze di “sballo” (non è un caso che si siano combattute guerre da queste parti per bloccare l’esportazione del papavero da oppio), in una nazione che sembrava avviata sulla via della pacificazione e della secolarizzazione.
Per questo, l’invasione sovietica dell’Afghanistan del 1979 fu traumatica per i nostri genitori: iniziava il declino dell’URSS nel tentativo di controllare questo stato incastonato fra le montagne, apparentemente poco interessante. C’è chi diceva che fosse per bloccare gli effetti della rivoluzione iraniana nella regione, chi per una naturale propensione della Russia a espandersi verso i mari caldi. Oppure una questione di sopravvivenza: avere un governo non allineato, in una zona che confinava con Cina e URSS non sembrava una buona idea. Fatto sta che dieci anni dopo, l’Armata Rossa lasciava l’Afghanistan con la coda fra le gambe. I governi comunisti (fantocci) di Babrak Khamal prima e di Mohammed Najibullah poi non avrebbero lasciato nessuna traccia tangibile. L’Armata Rossa si ritirava il 12 febbraio del 1989, a novembre sarebbe caduto il Muro. Gli americani, che avevano fatto di tutto per mettere al potere i ribelli Mujahiddin, vedevano a loro volta i “loro guerriglieri” rovesciati dopo meno 10 anni dai molto più estremi Taliban.
E arriviamo a quello che ci è più familiare: l’11 settembre lo ricordiamo quasi tutti. La vittoriosa avanzata degli Stati Uniti, la coalizione dei volenterosi, le elezioni libere. Ci ricordiamo però anche il balbettante governo di Hamid Kharzai, l’assassinio di Enzo Baldoni, la stanchezza di uno stato in cui non sembrava possibile esportare la democrazia. Karzai, che doveva essere l’emblema di una nuova, forte stagione riformista e che invece sembrava un personaggio bidimensionale, messo lì solo per compiacere gli occidentali (cosa non troppo lontana dalla realtà, fra l’altro). Inoltre, ora gli Usa avevano un altro fronte in cui combattere, quello iracheno. E di conseguenza una stanchezza maggiore, la morte di Bin Laden che ha solo permesso un indebolimento di Al Qaeda a favore dell’ISIS, Trump che cerca di scappare da questa gabbia trattando con gli stessi Taliban. Gli Usa non vogliono più fare il gendarme del mondo, un bel problema per tutti. Alla fine, non sarà Trump a essere ricordato per il ritiro degli americani dall’Afghanistan, ma Joe Biden. Certo, però, nemmeno il peggior pessimista si aspettava un epilogo così umiliante per questo ritiro.
Per chi non avesse aperto un sito di news o visto la TV nelle ultime settimane, i talebani, in meno di un mese, hanno riconquistato il paese. Il governo di Ashraf Ghani non ha opposto nessun tipo di resistenza, i militari addestrati dagli americani sono scappati o si sono uniti ai Taliban. Kabul è caduta senza neppure combattere e già ci si prepara all’esodo di migliaia (forse milioni) di uomini e donne verso Usa ed Europa. Ghani è scappato, non si sa nemmeno dove. Il governo di transizione ha già proclamato l’emirato islamico.
Ora, la storia non dispensa lezioni. Però qualche pensierino dovrebbe invitarci a farlo. In primo luogo: l’Afganistan non è un paese facile da conquistare. L’ultimo a riuscirci è stato Tamerlano, detto Timur lo Zoppo. Uno che faceva piramidi di teschi nelle città che non si consegnavano a lui, che ha portato in giro per l’Asia in una gabbia Bayezid, il legittimo sultano ottomano e uno dei più grandi generali dell’epoca, che aveva osato sfidarlo. È morto nel 1405 e la sua base operativa era a Samarcanda, a soli 800 km di distanza. Da allora, ogni tentativo di conquistare quelle montagne è fallito. Qualcosa vorrà pur dire.

Inoltre, il tratto comune di britannici, sovietici e americani è stato il desiderio di imporre governi a loro immagine e somiglianza. Magari molto più aperti, progressisti e presentabili rispetto a quelli che c’erano prima, ma totalmente sconnessi dalla società afghana. E questo si è visto a ogni ritiro dell’invasore di turno: un inarrestabile movimento popolare, represso per anni, che marcia inarrestabilmente verso la capitale Kabul. La restaurazione (escluso il periodo post-sovietico) del governo precedente, infine, che porta di solito i fantocci alla fuga, verso il paese che li ha sostenuti: Kharmal è morto nel 1996 a Mosca, per esempio.
Molte analisi, in questi giorni, si stanno concentrando sul fallimento strategico statunitense. Questo è evidente, così come evidente è il nostro fallimento, in quanto membri della coalizione. Però non è solo questo: è anche la cartina tornasole di una certa idea di politica estera post-coloniale. Sarebbe forse il caso di farsi un esame di coscienza e capire se l’arte di “mettere bandierine” e governi “amici dell’Occidente” a forza non sia una formula arrivata al capolinea. Che è poi quello che si è fatto prima in maniera molto diretta con le guerre coloniali, poi con la Guerra Fredda e, infine, con l’idea bislacca che la democrazia si possa esportare e che sia una merce che si può imporre ad una nazione a prescindere dalle sue peculiarità sociali, politiche e culturali. Non pensiamo che sia un problema solo degli americani: anche le guerre che stiamo conducendo in Libia o in Siria sono la cartina tornasole di una certa “spocchia” di noi europei sul tema. Inoltre, semmai tutto questo fosse stato vero un tempo, l’Occidente non ha più la potenza demografica e strategica per esportare nulla a nessuno. Che si chiami “missione civilizzatrice”, “Guerra Fredda” o “Esportazione della democrazia”, sembra giunto al capolinea il disegno dell’uomo occidentale di dire al Terzo Mondo cosa è meglio per lui.

E qui veniamo al punto centrale della questione: in ottant’anni di guerra in Afghanistan, i britannici hanno visto la loro potenza di nazione coloniale in costante calo; i sovietici sono crollati dopo 10 anni di conflitto snervante in un paese tutto sommato piccolo. Cosa attende gli Stati Uniti, ora? Dall’America si guarda con un certo sconforto a quello che sta succedendo, a maggior ragione perché fra poche settimane sarà il ventesimo anniversario dell’11 settembre. Malgrado questo, i sondaggi fotografano una percentuale fra il 60% e il 75% circa di statunitensi favorevoli al ritiro. È quella che gli analisti chiamano Empire’s fatigue, ovvero la stanchezza degli americani a fare il “poliziotto del mondo”. È una delle ragioni per cui Trump ha vinto le elezioni nel 2016, promettendo il ritiro dall’Afghanistan e un maggior contributo della NATO alla difesa di Medio Oriente ed Europa. Ed è una richiesta che, in modo meno duro, ha fatto anche Joe Biden agli europei. Perciò, sebbene sembri difficile profetizzare la fine dell’Impero Americano, questa potrebbe essere la fine di una certa visione degli Stati Uniti: quella di una nazione che interviene a ogni latitudine per “difendere la democrazia” (che il caso vuole corrisponda ai suoi interessi geopolitici). Sarebbe un mondo più autonomo di prendere le sue decisioni, ma anche potenzialmente più caotico, nel vuoto di potere lasciato dagli americani.
Ultima cosa: che succederà all’Afghanistan ora? Non è nell’interesse di nessuno, dei Taliban in primo luogo, ricominciare a fomentare il terrorismo a livello internazionale o fare chissà quale politica aggressiva verso le nazioni vicine. Perciò saremo probabilmente costretti a vedere un paese che fa dei passi indietro spaventosi a livello di diritti umani, ma che starà un po’ in disparte a livello di politica internazionale. Ha colpito, chi ha ascoltato l’intervista della BBC al portavoce dei talebani, Suhail Shahin che ha dichiarato: «Noi rispetteremo i diritti delle donne: gli sarà permesso di avere accesso all’istruzione e al mondo del lavoro, a patto che portino l’hijab [il velo]». Malgrado queste dichiarazioni confortanti, però, nelle province occupate dai talebani sono moltissime le donne espulse dalle università. In prospettiva, potrebbe anche crearsi una situazione simile all’Arabia Saudita: un paese con una politica reazionaria, ma che difficilmente si schiera apertamente contro i valori considerati non negoziabili dagli occidentali. In compenso, quest’opera probabilmente andrà avanti e sarà anche abbastanza violenta. Fra l’altro, la liquefazione dell’esercito di Ghani non lascia presagire nessun tipo di resistenza a quest’operazione, almeno sul breve termine.

L’unico paese che potrebbe opporsi, in modo efficace, ai disegni dell’Emirato islamico, è la Cina. In effetti, un emirato islamico ai confini del Paese, in un momento di scontro così forte, rischierebbe di far venire strane idee agli uiguri, contro i quali Pechino sta facendo una politica repressiva durissima. Fra l’altro, la causa dello Xinyang gode di un amplissimo sostegno internazionale, che complica parecchio la situazione dei cinesi. Però, senza una coalizione alle spalle e con le esperienze negative dell’ultimo secolo e mezzo, c’è da scommettere che Pechino ci penserà due volte prima d’intervenire: c’è gente molto pragmatica, da quelle parti.
Autore
Camillo Cantarano
Autore
Amo il data journalism, la politica internazionale e quella romana, la storia. Odio scrivere bio(s) e aspettare l'autobus. Collaboro saltuariamente con i giornali, ma mooolto saltuariamente