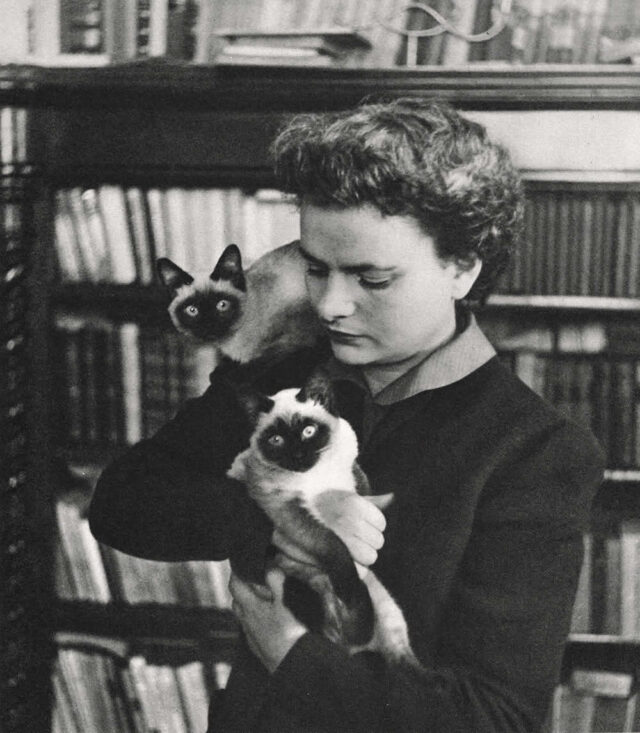L’America’s Cup approda a Bagnoli: una notizia accolta con entusiasmo da molti, soprattutto in vista delle celebrazioni per i 2.500 anni dalla fondazione della città di Napoli. Un evento sportivo di portata mondiale, che potrebbe offrire un’occasione straordinaria di visibilità internazionale e rilancio economico per la città. Tuttavia, accanto alla legittima soddisfazione, occorre evitare facili entusiasmi e interrogarsi con lucidità sulle implicazioni che questa scelta comporta, specialmente in un territorio complesso come quello flegreo.
Il punto critico non è la manifestazione sportiva in sé, ma il modello di sviluppo che potrebbe innescare. Il rischio è quello di costruire attorno all’America’s Cup un paradigma di crescita fondato su una turistificazione intensiva, già auspicata da alcune componenti dell’attuale amministrazione comunale. In tale ottica, l’evento diventa non un fine, ma un mezzo per introdurre trasformazioni urbane e sociali che rischiano di eludere il confronto con la cittadinanza.
Le cifre in gioco sono imponenti. L’impatto economico complessivo stimato per Napoli e la Campania si aggira intorno ai 700 milioni di euro, con un investimento diretto previsto di circa 100 milioni, di cui il 70% speso localmente. Si stimano tra 1,5 e 1,7 milioni di visitatori in città durante i 60 giorni dell’evento, con una spesa turistica diretta di circa 370 milioni di euro. A ciò si aggiungono le forniture, la logistica e gli investimenti infrastrutturali, con un ritorno economico che, almeno sulla carta, sembra garantito.
Tuttavia, numeri e previsioni non bastano a garantire un impatto positivo duraturo. L’esperienza insegna che grandi eventi, se non accompagnati da una visione di lungo termine e da un solido coinvolgimento civico, rischiano di lasciare poco oltre l’effimero. Napoli ha già conosciuto occasioni mancate: basti pensare all’eredità delle Universiadi o alla trasformazione incompiuta dell’area orientale dopo Italia ’90. Le infrastrutture vengono spesso realizzate in fretta, i territori snaturati, le promesse disattese. Le cosiddette “grandi opere” diventano spesso grandi occasioni perdute, che lasciano dietro di sé cemento, consumo di suolo e poco altro.
In particolare, suscita preoccupazione la possibilità che decisioni fondamentali per il futuro di Bagnoli vengano prese in modo verticistico, senza coinvolgere comitati civici, associazioni, realtà sociali e comunità locali. La cittadinanza organizzata chiede da anni democrazia partecipativa e processi realmente inclusivi per la rigenerazione del quartiere. I tempi ristretti dell’evento rischiano invece di comprimere ulteriormente gli spazi di confronto e di trasparenza. La mancanza di un vero dibattito pubblico, unita alla rapidità esecutiva imposta dalla manifestazione, potrebbe sacrificare esigenze fondamentali in nome dell’urgenza e dell’immagine.
Dalle recenti dichiarazioni del Sindaco di Napoli emerge l’ipotesi di utilizzare la colmata di Bagnoli come area di attracco per le grandi imbarcazioni. Una scelta, se confermata, che potrebbe rappresentare il primo passo verso la costruzione di un porto turistico. Un progetto fortemente contestato da anni, in quanto ritenuto incompatibile con la balneabilità pubblica e gratuita del litorale, una rivendicazione storica delle comunità locali. La battaglia per un mare accessibile, pulito e restituito alla cittadinanza ha rappresentato un punto fermo nelle mobilitazioni civiche degli ultimi trent’anni. Rinunciarvi significherebbe tradire un patto simbolico con la città. Significherebbe, soprattutto, ignorare la memoria collettiva, i desideri di chi ha abitato, lottato e creduto in un futuro diverso per Bagnoli.
Inoltre, l’indotto generato da un evento di tale portata potrebbe produrre un ulteriore aumento dei canoni di locazione, già oggi particolarmente elevati in alcune zone dell’area flegrea. Il rischio è quello di un processo di gentrificazione forzata: lo sviluppo turistico potrebbe tradursi in espulsione per i ceti popolari, storicamente radicati nel territorio. A fronte di grandi yacht e hotel di lusso, chi garantirà il diritto a restare nei propri quartieri? Un territorio trasformato in vetrina rischia di perdere la propria anima, la propria memoria e le proprie relazioni di prossimità. Il turismo, quando sfugge al controllo, diventa una forza centrifuga che allontana gli abitanti, impoverisce i legami e alimenta l’ineguaglianza.
Sul versante della sicurezza ambientale e geologica, infine, si registra un silenzio inquietante. I Campi Flegrei sono da anni classificati come zona ad alto rischio vulcanico, con allerta gialla attiva dal 2012. Il governo ha recentemente stanziato oltre 400 milioni di euro per misure urgenti di prevenzione e messa in sicurezza. Si è anche parlato di dichiarare lo stato di emergenza nazionale per il bradisismo. Eppure, proprio in quest’area si prevede di concentrare centinaia di migliaia di persone, con un carico infrastrutturale notevole. Non è paradossale? Come si può giustificare la scelta di un luogo tanto fragile per ospitare uno degli eventi più esposti e affollati al mondo?
Progetti seri, come quello elaborato dal gruppo Nurige per una gestione convivente del rischio vulcanico, non sono stati nemmeno presi in considerazione. Nel frattempo, le famiglie già evacuate a causa delle scosse attendono risposte concrete su sistemazioni e prospettive. L’impressione, purtroppo, è che prevalga ancora una logica emergenziale e spettacolare, più orientata alla visibilità mediatica che a un reale progetto di rigenerazione sostenibile. In una città che vive ciclicamente tra emergenza e propaganda, il rischio è che anche questa occasione diventi l’ennesima passerella.
A ciò si aggiunge una certa retorica della “grande occasione” che finisce per azzerare il dissenso e marginalizzare le voci critiche. Ma una città non cresce sulla base dell’omologazione, bensì nel conflitto democratico, nel dialogo tra istanze diverse, nella capacità di costruire consenso attraverso il confronto. L’America’s Cup potrebbe essere molto più di una regata: potrebbe essere l’occasione per sperimentare un modello nuovo di governance urbana, partecipato, inclusivo, attento al territorio e alle sue contraddizioni. Ma per farlo servono coraggio politico, trasparenza, ascolto vero.
Accogliere l’America’s Cup a Napoli potrebbe essere un’occasione storica, ma solo se sapremo trasformarla in un banco di prova per un modello di città diverso: giusto, partecipato, ecologicamente consapevole. Diversamente, rischia di diventare il simbolo di una scelta miope, fondata su logiche esclusive, che aumentano le fratture sociali ed economiche già profonde. Una città come Napoli non ha bisogno solo di eventi, ma di visione. Non di grandi vetrine, ma di profondi processi trasformativi.