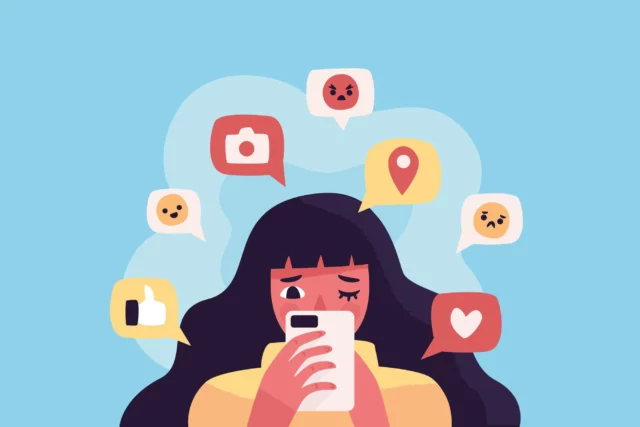Alessandra Chiricosta è filosofa, esperta di Gender Studies, storica delle religioni e specializzata in culture del Sudest asiatico continentale dell’Asia Orientale, dove ha compiuto ricerche sul campo per molti anni. Si occupa di filosofia interculturale, di questioni gender in prospettiva de-coloniale e transculturale. È autrice del libro Un altro genere di forza in cui indaga il nesso tra genere e forza ed elabora, grazie anche alle filosofie orientali, un’alternativa femminista decostruttivista alle pratiche di combattimento. Ha collaborato all’elaborazione della mostra Moving in space without asking permission, prima mostra italiana dell’artista Andrea Bowers alla Galleria di Arte Moderna di Milano. In questa occasione ha tenuto un talk alla GAM da cui parte questa intervista.

Dopo il talk alla GAM in occasione della mostra di Andrea Bowers sono rimasta molto colpita dalla tua definizione di forza, anche in relazione alle arti marziali: io stessa ho praticato karate per cinque anni, e ripensando a quell’esperienza mi sono ritrovata molto nelle tue parole. Ti andrebbe di spiegarci come pensi debba essere rielaborato il concetto di “forza”?
«La riflessione sulla forza nasce da una testimonianza personale: la prima volta che sono salita su un dojo, a 15 anni, praticavo ju jitsu. Parentesi, negli anni ho scoperto che proprio il ju jitsu era stato usato dalle suffraggiste come tecnica di combattimento. La questione si sviluppa su più livelli: come ho spiegato anche nel titolo del mio libro Un altro genere di forza, osservare il nesso tra forza e genere, che è culturalmente declinato, mi ha fatto capire perché provassi un fastidio quando sentivo discorsi su forza e combattimento. Il fastidio nasceva da un mancato riconoscimento della mia esperienza. Questo accade perché culturalmente abbiamo connesso il concetto di forza a quello di un solo genere, cioè quello maschile, che privilegia una delle possibili manifestazioni di quella che noi chiamiamo “forza combattente”.
Le declinazioni del concetto di forza sono invece tantissime ed è un campo ancora da esplorare. Per ora abbiamo agito prevalentemente la forza virile che, come ci ricorda Simone Weil in Iliade. Il poema della forza, agisce nell’ottica di schiacciare, annichilire, distruggere per assicurarsi la propria soggettività. Perché in quest’ottica solo tramite l’annichilimento del nemico posso affermare la mia superiorità e questo mi restituisce soggettività. L’idea della forza quindi viene declinata in modo di coincidere con la violenza. Anche quando parliamo di forza difensiva, è come se venisse separato un momento di una stessa identica dinamica. Per me la questione quindi non è se difendi o attacchi, ma come lo fai».
Non c’è quindi futuro per una forza violenta? Da dove dovremmo ricominciare a stabilire il nostro rapporto con i diversi tipi di forze?
«Il destino di una forza che ha come suo fine l’annichilimento finisce per pietrificare anche il presunto vincitore. Al contrario, l’esperienza delle pratiche combattenti che ho fatto mi parlava anche di altro. Ovviamente non basta lo strumento, bisogna riconfigurare tutto lo scenario di partenza: secondo me esistono pratiche più indicate di altre. Le pratiche orientali ad esempio ci insegnano a ripensare da capo il concetto di conflitto, anche ampliandone i termini. Che tipo di posizione prendo in un conflitto? Che tipo di strategie posso adottare? La cosa che notiamo è che qualsiasi organismo vivente ha delle sue forme di gestione del conflitto, senza entrare in contrasto con il resto dell’ecosistema: si mettono in atto sia pratiche che noi definiremmo “di cura”, sia spinte per allontanare gli elementi nocivi.
Il problema è che nella specie umana è stata operata una divisione di queste due funzioni in base al genere. La parte combattente è stata privata di una sensibilità, ascolto e capacità di negoziazione e quindi è sconfinata nella violenza, mentre gli elementi di cura e protezione sono stati affidati al genere femminile rendendolo potenziale vittima di soprusi, anzi insegnando che quei soprusi sono giusti. Questo sistema è caro alla metafisica occidentale, come ci fanno notare molti filosofi orientali, perché è organizzato secondo contrapposizioni dirette e binarie. In questo binarismo i nostri tentativi di riguadagnare una diversa concettualizzazione del rapporto tra genere e forza è molto difficile, perché si tende ad accettare il paradigma della forza virile proiettandolo su un altro genere, quello femminile».
Negli anni ‘70 infatti in Italia si è aperto un dibattito, anche in ambito artistico, riguardo come le donne si dovrebbero rapportare ai linguaggi maschili. Ad esempio, nel mondo dell’arte quando Carla Lonzi afferma di rigettare l’arte in quanto linguaggio maschile. Nelle arti di combattimento si può risolvere questo dilemma?
«“The master’s tools will never dismantle the master’s house”: sotto certi aspetti è fortemente vero. Però dobbiamo chiederci quali sono questi strumenti: non possiamo buttare tutto, sono linguaggi che abbiamo attraversato e che ci attraversano. Anche Carla Lonzi, non immagina un mondo in cui viene spazzata via ogni cosa e si riparte da zero. Bisogna iniziare un’opera di decostruzione in cui capiamo cosa vogliamo tenere e cosa no. Per questo anche io parlo di “autocoscienza combattente femminista”, perché credo che sia necessario usare degli strumenti e partendo da quelli elaborare nuovi scenari. Sono molto d’accordo nel dire che non basta replicare le dinamiche patriarcali perché sono nate in una struttura che è pensata per escluderci.
Per quanto riguarda il combattimento, da una parte propongo un tipo di pratica che ricalca un percorso femminista destrutturante, allo stesso tempo sono fermamente convinta che la forza sia declinabile in più modi a seconda delle nostre caratteristiche. In quanto donna, perché sappiamo che le donne non sono una categoria omogenea, puoi incarnare la forza della roccia, salda, opprimente, pesante; ma puoi anche ispirarti ad un tipo di forza, ad esempio quella dell’acqua che è una forza di contatto, non di sottrazione. Questo per dire che puoi essere roccia, se senti di essere roccia, se ne hai le caratteristiche. Ogni corpo-realtà deve poter decidere tra le declinazioni alternative del concetto di forza, sia nella teoria che nella pratica. Nel senso che è facile dire “fatti acqua”, ma cosa vuol dire? Questo ce lo spiegano molto bene le filosofie orientali».
Non è un caso che è proprio dall’oriente che arriva l’oroscopo, che prende i quattro elementi. Le caratteristiche di ognuno di essi vengono viste come possibili motori positivi nella vita di una persona.
«Esatto! L’acqua nella sua pratica non ha forma, è sempre in movimento, non si fa catturare dalla presa della roccia. Questa è la sua parte difensiva, nella sua parte offensiva rimane aderente, sgretola, corrode, penetra nelle zone più deboli della roccia. Se ci facciamo ispirare dalla strategia dell’acqua capiamo che l’erosione avviene tramite contatto, non tramite sottrazione. Altri generi di forza cercano quindi di uscire dalla contrapposizione binaria che crea questa immagine di monoliticità del nemico. Cominciamo quindi a pensare a forze non-antropiche, che non sono tanto metafore quanto possibilità a cui ispirarsi. Le arti di combattimento orientali spesso si ispirano ad elementi non umani, animali e naturali, come la forza dell’albero di cui parlo nel mio libro.
La forza dell’albero nella filosofia è sicuramente un tema ricorrente, ad esempio in Spinoza e Angela Putino, che tratta la necessità di trovare un proprio equilibrio dinamico. L’albero rompe un’altra dicotomia, ossia la convinzione che si possa spingere solo verso l’alto o verso il basso. Al contrario l’albero ha due spinte in direzioni opposte, la radice che spinge in basso permette l’ascesa della linfa verso l’alto. Queste due spinte non sono in contrasto, ma in armonia. L’albero non è privo di strumenti di difesa o di attacco, se come attacco intendiamo l’insediamento in un territorio. Ci insegna che bisogna conoscersi per trovare il proprio equilibrio e scegliere come incanalare la nostra forza. Abbiamo interiorizzato così tanto che alcuni corpi sono “inferiori” da non riuscire ad immaginare un nuovo modo per gestire i conflitti».
Infatti quando dicevo di fare karate, forse perché oltre che donna sono anche molto minuta, la reazione più comune era “brava, così impari a difenderti!”. Ma io non l’ho mai fatto per quello, non ci avevo neanche pensato.
«Hai completamente ragione, è un’esperienza molto comune. Quest’estate in un campo estivo ho chiesto ad alcune ragazze perché lo facessero, e alcuni insegnanti hanno suggerito: “perché così imparano a difendersi”. Innanzitutto non dovevano parlare al posto di quelle ragazze e poi, parlo per me, lo faccio perché mi diverte. Perché il mio corpo di quindicenne si sentiva libero, si divertiva, ha percepito una scarica di endorfine e ha pensato: “voglio farlo per tutta la vita”. Non indosso un’armatura che mi farebbe perdere di sensibilità, anzi faccio esattamente il lavoro dell’albero: allargarmi, capire cosa c’è nelle mie corde. Certo, accade anche che incontri qualcuno che vuole impormi dei limiti, ho imparato a gestire questo conflitto. In ogni caso, la tecnica di combattimento non nasce da dinamiche di paura.
Ma non è casuale che a te, a me e alla gran parte delle donne rispondano così. Perchè in una società che ha tolto l’orizzonte combattente dall’ambito della femminilità, se tu ammetti che il combattimento è qualcosa nelle tue corde, stai forzando una definizione normativa. A quel punto ho studiato come nel corso della storia siano state trovate delle strategie di “riaddomesticamento” di questo fenomeno destrutturante. L’eccezionalismo, che ammette l’esistenza di donne combattenti ma specifica che sono casi rari; la negazione del fenomeno, come nel caso delle amazzoni che vengono considerate creature mitologiche; la feticizzazione; la legittimazione, che ammette donne combattenti solo perché in quanto deboli devono imparare a difendersi. Ma cosa c’è in quella difesa? Sopravvivere, restando nell’idea che la risposta alla paura sia la forza virile, che nasce proprio dall’idea di esorcizzare la paura tramite l’annichilimento dell’altro».
La pratica combattente può quindi essere altro dalla violenza, anche quando viene espletata sotto forma di difesa
«Non vengono esplorati altri aspetti che non partono dalla paura. All’interno della mostra abbiamo realizzato un’installazione, una “lezione” di autocoscienza combattente realizzata nella sala da ballo. In questa performance ripensiamo uno spazio “addomesticato”, una sala da ballo dell’Ottocento, in cui i corpi riconfermavano i ruoli di genere e la sottomissione femminile. Riprendiamo questo spazio, come dice il titolo della mostra Moving in Space without Asking Permission mostrando il piacere, il divertimento e anche la fatica di un processo di riacquisizione dello spazio e della nostra corporeità. Lo spazio viene ridefinito dal movimento stesso e così avviene la dinamica di trasformazione. Il mio centro non è “distruggo il mio avversario” ma “ritrovo me stessa” con delle pratiche di conflitto anche sono anche fisiche».
«Una delle strettoie in cui ci troviamo essendo una cultura che ha diviso corpo e mente, è l’inferiorità del corpo sulla mente e la sua mancanza di autonomia. Questo crea dei problemi anche quando si tratta pratiche di combattimento che vengono immediatamente bollate come violente, per il solo fatto di includere un conflitto fisico. Riabilitare che ci possano essere atti corporei forti ma non violenti, come la forza di contenimento, aiuta a comprendere che la violenza non è l’unica forza che possiamo agire».
Un tema che non abbiamo toccato è quello storico, è possibile fare un breve riassunto della storia del combattimento femminile?
«Il punto è proprio la negazione. Il mythos della forza viene fatto coincidere con quello della forza virile, ma questa analogia regge solo negando la realtà storica. Le Amazzoni sono l’esempio più chiaro: si pensa a loro come creature leggendarie ma sono esistite realmente. È ovvio che siano state mitizzate, ma la loro esistenza è attestata dagli storici dell’antichità: aver trionfato sulle Amazzoni era vista come una delle più grandi conquiste dell’esercito ateniese.
Allo stesso modo viene negato il contributo storico delle donne nelle arti di combattimento. Ho avuto la fortuna di vivere in Vietnam per anni e lì la tradizione si è sempre identificata come una forza che, diciamo, corrisponde al termine cinese “ying”. Una forza femminile, morbida, d’acqua. Il Vietnam nella sua storia si riconosce non solo come una forza femminile, ma anche attraverso personaggi femminili come le sorelle Trung. In Vietnam la figura delle sorelle Trung e della loro rivoluzione è stata esaltata mostrando come i deboli possano far leva sulla loro forza “acquosa” per vincere. La figura femminile combattente non viene quindi negata o rimossa, ma anzi celebrata e mitizzata».

Un’ultima domanda: cosa puoi dirci sulla mostra di Andrea Bowers alla quale hai collaborato?
«Il rapporto con Andrea è stato meraviglioso, una collaborazione molto profonda. Pensavo si trattasse solo di una chiacchierata invece è stato molto di più. Anche riguardo quello che mi chiedevi prima: lei è stata grandiosa ad interpretare il monito di Lonzi, ha risignificato a tutto in una chiave molto accessibile e ironico. Come ci insegna la medicina cinese, se c’è un eccesso di paura ossia di acqua, va bilanciato con il fuoco, quindi la risata e il piacere. Io non faccio le cose perché devo – quello ce lo ha insegnato il patriarcato – lo faccio per piacere, per conoscermi. Ha questa postura femminista intersezionale e postcoloniale, arriva e si mette a disposizione. La mostra è stata allestita all’insegna del divertimento, come diceva anche Rosi Braidotti infatti “non bisogna sempre indulgere nelle passioni negative”. Il divertimento, la gioia, anche la gioia della lotta, sono state fondamentali».
Autore
Romana naturalizzata milanese, attualmente trapiantata in Olanda. Leggo e scrivo (tanto) e parlo (troppo) per lo più di come l'arte possa essere uno strumento per costruire una società più giusta. Femminista arrabbiata, ma anche astrologa (praticamente tutto ciò che gli uomini etero odiano, ho anche la frangia)