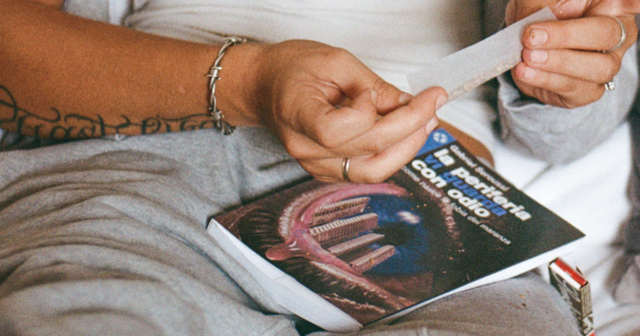Le disuguaglianze economiche in Italia sono in forte aumento da almeno due decenni, sia per quanto riguarda i redditi che la ricchezza. Quest’ultima, in particolare, non risulta più derivare da crescita economica e retribuzioni lavorative, quanto piuttosto da eredità accumulate a partire dal secondo Dopoguerra. Quando il valore economico di un paese dipende sempre di più dal trasferimento di benessere passato a discapito del capitale umano e sociale presente la mobilità di classe rallenta, favorendo una realtà sempre più oligarchica, stagnante e iniqua.
Nel suo best seller “Il Capitale nel ventunesimo secolo”, Thomas Piketty, economista e ricercatore francese divenuto poi una delle voci accademiche più dirompenti in tema di disuguaglianze, descrive così il ruolo dell’eredità nella concentrazione delle ricchezze individuali: “Quando il tasso di rendimento del capitale è significativamente più alto del tasso di crescita medio dell’economia, è inevitabile che l’eredità acquisita dal passato predominerà sul risparmio costruito nel presente”. In un mondo come quello europeo, caratterizzato da profitti finanziari e rendite immobiliari in costante aumento a fronte di una bassa (se non nulla) crescita dei salari, ne consegue che quando una fetta di ricchezza sempre maggiore finisce nelle tasche di grandi investitori e proprietari di immobili questa verrà poi più facilmente concentrata nel tempo.
Egli poi rimarca la recente inversione di tendenza sul peso del valore delle eredità in rapporto al reddito nazionale francese, sottolineando come, a partire dagli anni Ottanta, questo stia ritornando a livelli osservati nelle aristocrazie di rentiers di metà Ottocento. Ampliando l’analisi a livello europeo, in un contesto di stagnazione dei redditi da lavoro, bassa natalità e crescita dei valori delle attività immobiliari e finanziari, il professore della HESS di Parigi stima uno scenario futuro in cui la quota dei flussi ereditati sul reddito nazionale si possa attestare attorno al 17% entro il 2040.
A distanza di circa dodici anni, The Economist pubblica un numero interamente dedicato al ritorno dell’ereditocrazia, ossia della trasformazione in atto nelle economie avanzate da società largamente dipendenti da ricchezza generata dai redditi lavorativi a paesi in cui sono le successioni intergenerazionali a formare la maggior parte di benessere accumulato. Nel solo 2024, secondo il periodico inglese, sarà di circa 6 mila miliardi di dollari il valore complessivo ereditato, pari a poco più del 10% del reddito nazionale medio nello stesso anno. Tra i paesi del G10 analizzati, l’Italia primeggia avendo già raggiunto il tasso più vicino alle stime previsionali di Piketty, ossia un valore complessivo di asset ereditati che sfiorano il 20% del reddito totale, come riportato in un recente studio di Salvatore Morelli. Quasi un quinto del prodotto generato a livello nazionale è quindi equiparabile alle sole successioni ereditarie (e donazioni) che assumono ora dimensioni più che doppie rispetto a soli trent’anni fa – la quota del 1995 era vicina al 9%. Il lavoro diventa sempre meno rilevante come fonte di risparmio e riscatto sociale in uno scenario di stagnazione economica e di bassa mobilità che rischia di riportare la fantasia alla Francia arrivista di Balzac o alla Sicilia oligarchica delle novelle di Verga, piuttosto che a periodi di dinamismo economico inclusivo come quelli vissuti dai baby boomer e millennials.
La prima e più rilevante conseguenza di una trasformazione così radicale del tessuto socioeconomico sarebbe, come già anticipato, un inevitabile inasprimento delle disuguaglianze di reddito e di patrimonio. Considerando inoltre le attuali tendenze demografiche strutturali come l’invecchiamento e il calo di natalità già registrati nella maggior parte dei paesi europei, ne consegue che le ingenti quantità di patrimoni costruite negli anni del boom economico verranno prossimamente ereditate da una fetta sempre minore, e quindi più concentrata, di cittadini. Aggiungendo all’equazione gli apprezzamenti e la crescita dei beni immobiliari degli ultimi decenni si può intuitivamente spiegare gran parte dell’ampliamento delle disparità economiche che da almeno trent’anni a questa parte stanno interessando il vecchio continente.
In Italia, ci ricorda un report di Tortuga, la ricchezza media appare ben più concentrata nelle mani di pochi rispetto a soli tredici anni fa: non solo il numero di miliardari è aumentato da 10 a 71 ma il 10% di popolazione più ricco possiede oggi il 60% del patrimonio totale. Alla metà più povera, che conta quasi 30 milioni di persone, spetta il 7%, valore pressoché immutato nel periodo in considerazione. Il nostro paese si classifica attualmente tra i più diseguali in UE e l’aspetto che desta maggior preoccupazione è l’incremento della quota di patrimonio detenuta dalle fasce più ricche, doppia rispetto alla media europea. I patrimoni netti quindi aumentano, ma non vengono distribuiti e finiscono per concentrarsi sulla punta della piramide sociale. Tra le cause più citate, appunto, la forte predominanza delle eredità che in Italia sono paradossalmente tassate con aliquote che vanno dal 4 all’8 percento, tra le più favorevoli d’Europa (basti pensare che Belgio, Spagna e Svizzera hanno regimi fiscali che prevedono fino all’80 percento di tassazione). Lo stesso studio di Tortuga riporta che nel 2023 il gettito complessivo derivante dalle imposte di successione è stato inferiore al 0,3%, un valore che scompare di fronte all’1,3% della Francia e che rende di fatto l’Italia un paradiso fiscale per ereditieri. D’altra parte, sul fronte dei redditi lavorativi, le entrate fiscali derivanti dalla tassazione dei salari, quindi l’IRPEF, costituiscono attualmente il 70% del totale.
Per arginare un potenziale sconvolgimento del patto sociale, possibilità sempre più allarmante alla luce delle tendenze qui discusse, sarebbe quindi necessario un ripensamento generale sul ruolo della distribuzione delle grandi ricchezze nel nostro paese, a partire da una riforma fiscale sulle successioni. Una tassazione progressiva, equa e condivisa all’interno di un progetto armonizzato sarebbe infatti un primo passo concreto non solo per aumentare le capacità di finanziamento del nostro governo ma per il raggiungimento di una più coerente distribuzione del benessere che ristabilisca giustizia sociale e, soprattutto, che permetta di sgravare lavoratori e dipendenti da un sistema fiscale poggiato interamente su di essi.