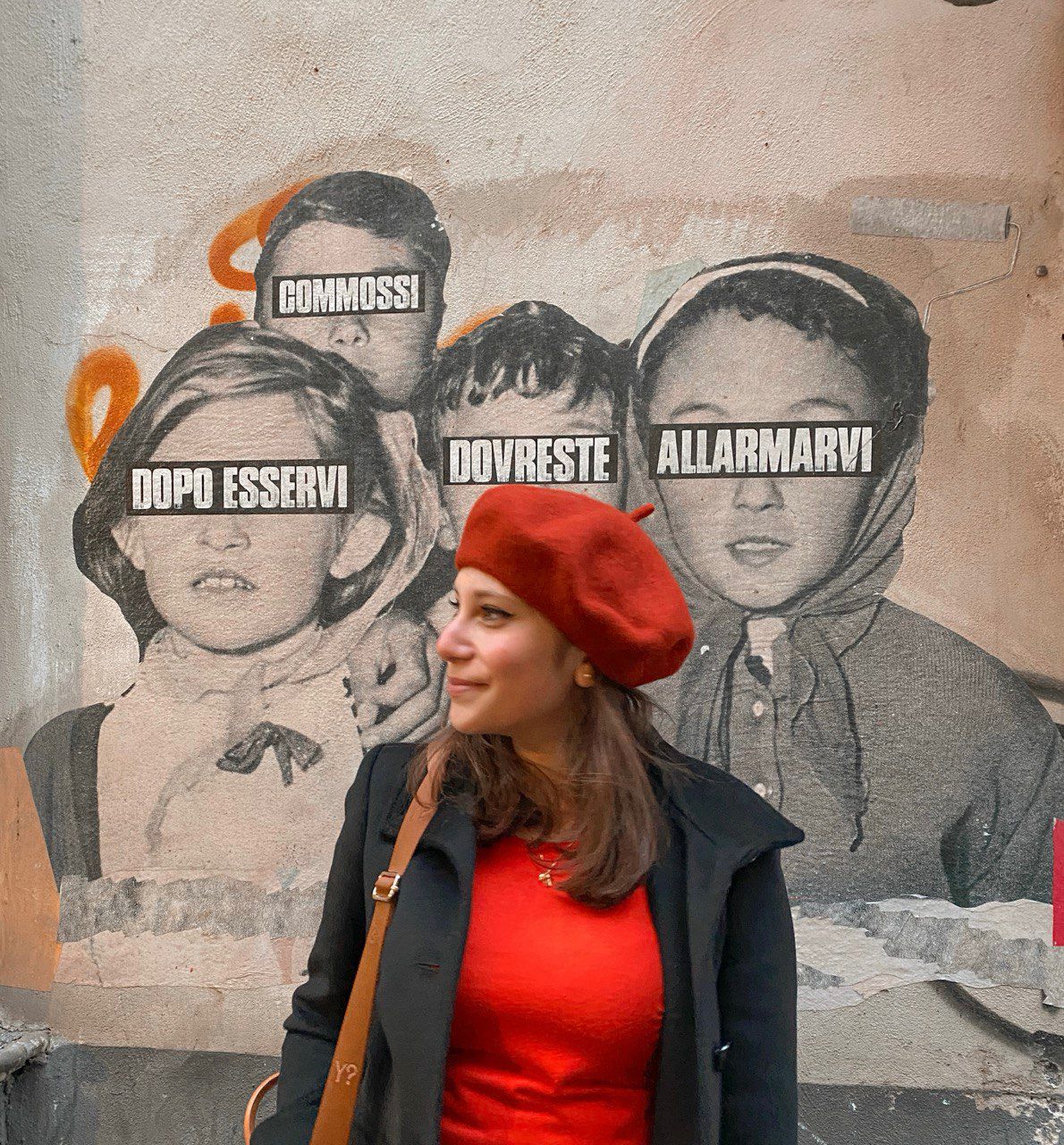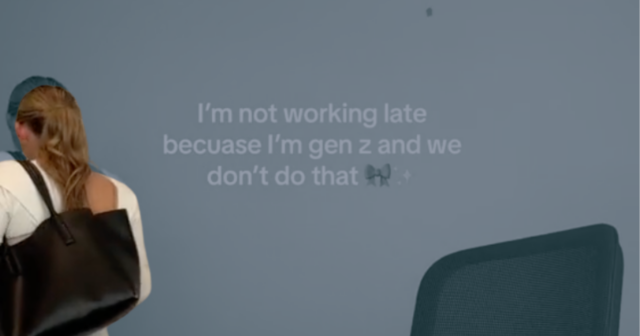Qualche mese fa Preply – una piattaforma di apprendimento linguistico online – ha pubblicato i dati emersi da un sondaggio, realizzato per scoprire quali dialetti italiani fossero meno apprezzati. Ne è risultato che il dialetto più fastidioso è il napoletano (raggiungendo il 22,8% di voti), seguito poi da sardo (11,4%) e siciliano (10,5%). Mentre, tra le inflessioni considerate maggiormente piacevoli si attestano il ligure e i dialetti emiliano-romagnoli.
Questa indagine, apparentemente innocua, lascia però ampio spazio ad interpretazioni strettamente collegate a quei fenomeni ascrivibili nell’ambito dell’antimeridionalismo. Non a caso, infatti, i voti a sfavore dell’inflessione partenopea derivano in gran parte dalle regioni centrali e settentrionali – anche se, come riporta Preply, “[persino] tra i residenti del luogo il dialetto napoletano non sembra godere di particolare popolarità”.
Ciò accade perché la cultura e l’opinione pubblica italiana sono ancora fortemente influenzate dai pregiudizi razzisti nei confronti delle persone meridionali, al punto da averle interiorizzate e, di conseguenza, normalizzate. Si tratta di processi talmente tanto radicati da essersi consolidati persino in coloro che subiscono tali discriminazioni (non a caso sempre dalla piattaforma emerge che a Cagliari e a Palermo a non apprezzare la propria cadenza sono rispettivamente il 16% e il 18% della popolazione).
I vari giudizi, più o meno negativi, relativi ai linguaggi e agli accenti del Sud Italia, rientrano in quei processi di marginalizzazione che le regioni in questione subiscono. Processi alimentati da alcuni stereotipi che vedono, per esempio, la cadenza dialettale come elemento tipico solo nei meridionali – mentre l’intonazione settentrionale viene implicitamente associata al modo corretto di parlare l’italiano standard. Da un’indagine linguistica condotta dalle docenti Francesca Bianchi e Silvia Calamai è emerso, infatti, che le lingue regionali percepite antiestetiche, sgradevoli e soprattutto scorrette sintatticamente sono proprio quelle del Sud, a differenza di quelle settentrionali generalmente considerate come migliori e più raffinate.
In realtà, simili considerazioni non hanno nulla a che vedere con l’oggettività ma, anzi, sono condizionate dal dominio politico, economico e culturale che il nord Italia ha avuto sul resto del paese. Anche i dialettologi Corrado Grassi, Tullio Telmon e Alberto Sobrero hanno sottolineato che, tra gli anni Ottanta e Novanta, la varietà glottologica maggiormente associata alla classe dominante era proprio il milanese poiché parlato nei centri di maggiore ricchezza economica – a differenza di quelle del Mezzogiorno associate invece ad arretratezza, povertà e di conseguenza ad un contesto di generale ignoranza.
Nel consolidare questi stereotipi – inevitabilmente sfociati in discriminazioni linguistiche dal taglio antimeridionale – un ruolo cruciale è stato giocato dai mass media e dalla tv generalista. Eppure, la responsabilità che le reti televisive hanno avuto, privilegiando determinati accenti a discapito di altri, è riscontrabile già a partire dagli anni Cinquanta, quando gli unici show trasmessi erano quelli in cui il fiorentino predominava. Lo si faceva con una finalità di natura pedagogica, con programmi pensati proprio per impartire lezioni linguistiche basilari alle masse che non sempre ultimavano gli studi.
Anche la tradizione cinematografica italiana è stata per molto tempo un vettore importante: gli studi di Cinecittà a Roma e la diffusione del cinema Neorealista hanno inevitabilmente dato più spazio alle inflessioni romane (con piccole eccezioni come le opere di De Filippo). Lo stesso accade quando, con la nascita di Mediaset negli anni Novanta, il baricentro televisivo veniva conteso tra la capitale e Milano, rendendo questi due accenti molto più presenti nell’immaginario mediatico collettivo a scapito di quelli meridionali, relegati al più alla sola funzione comica.
In altri casi, invece, quelle poche volte in cui si portavano sullo schermo film o fiction ambientati al Sud lo si faceva solo in relazione a temi legati alla criminalità organizzata. È il caso di produzioni pluripremiate come Gomorra, in cui – sia nel film di Garrone che nella serie di Sky – si raccontano le dinamiche di potere tipiche della camorra campana denunciate nel libro di Saviano. Ma è soprattutto il caso di prodotti molto più trash pensati per un target più ampio, come le saghe andate in onda su Mediaset (Squadra Antimafia, Il capo dei capi per citarne alcune) o i vari polizieschi Rai (a partire da La Piovra, titolo pioniere per quanto riguarda le fiction sulla mafia). Si tratta di prodotti molto in voga sui canali della tv generalista dei primi anni 2000 che, seppur hanno denunciato fenomeni negativi presenti tutt’oggi, hanno anche avuto il demerito di accostare una determinata cadenza ad ambienti di criminalità. Cadenze tra l’altro rese ancora più macchiettistiche e caricaturali dalle interpretazioni di attori non meridionali – basti pensare al linguaggio del Montalbano di Zingaretti che, nonostante i suoi sforzi, continua ad apparire forzato, specie se si confronta con il siciliano dei romanzi di Camilleri.
Eppure, dopo decenni di rappresentazioni marginali e fortemente negative, adesso inizia a farsi spazio qualche nuovo progetto cinematografico volto a ripulire l’immagine del meridione da una serie di narrazioni stereotipate, partendo, tra le altre cose, proprio da una cambio di registro linguistico: è il caso de L’amica Geniale – famosa ormai anche a livello internazionale – o di progetti meno noti come The Bad Guy di Prime Video. Si tratta di prodotti recitati rispettivamente in napoletano e siciliano (dunque lontani dal classico italiano regionalistico), interpretati da attori quasi esclusivamente “madrelingua” che hanno saputo restituire dignità a dei dialetti da sempre associati all’ignoranza e alla povertà.
In questi ultimi prodotti, difatti, la lingua diviene protagonista del racconto: le voci di Lila e Lenù rendono giustizia al napoletano, esprimendosi con una sintassi perfettamente in linea con i tempi storici e con le età delle protagoniste (l’italiano subentra solo quando Lenù, crescendo, va a vivere in Toscana e quando Margherita Mazzucco passa il testimone ad Alba Rohrwacher, l’unica attrice non campana nella serie).
Anche in The Bad Guys si verifica una situazione simile: il dark comedy di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, oltre a portare una ventata di novità con idee anti-convenzionali e una scrittura originale, rende unico il prodotto proprio grazie all’uso di un siciliano autentico. Le interpretazioni di Luigi Lo Cascio, Antonio Catania, Giulia Maenza e altri attori quasi esclusivamente siculi – così come la colonna sonora piena di cantautorato – sembrano adattarsi perfettamente al filone narrativo anticonformista e contribuiscono a creare una vera e propria parodia delle fiction italiane sull’antimafia. Queste scelte stilistiche hanno permesso, almeno in parte, di affrontare tematiche urgenti come la povertà, l’emancipazione femminile, la marginalizzazione, la criminalità dal punto di vista degli oppressi che, riappropriandosi della propria lingua, divengono soggetti e non oggetti della narrazione.
Questi esperimenti proposti dalla neo-tv e dalle piattaforme streaming non sono ovviamente gli unici realizzati nel corso degli anni: il lavoro di Massimo Troisi ha indagato a fondo la realtà di Napoli, così come alcuni film d’autore (A ciambra, Cristo si è fermato a Eboli con Gian Maria Volontè per dirne alcuni).
Eppure, si tratta di prodotti non pensati per un pubblico ampio, bensì per un’élite cinefila esperta. Il potere di serie come L’amica geniale sta invece nell’essere in grado di arrivare a chiunque, pur presentando peculiarità a cui la maggioranza del pubblico non è abituata, ma che sono diventate il suo punto di forza tanto da renderla un successo internazionale.
Ora, che si tratti di piccole eccezioni in un panorama televisivo tendenzialmente piatto, o di prodotti pionieri in grado di inaugurare generi nuovi, è ancora presto per dirlo: quel che è certo è che sono riusciti a sganciarsi dallo stereotipo meridionale-comorrista o meridionale-ignorante, riscattando il diritto di proteggere unicità linguistiche finora ignorate.
Autore
Rachele Liuzzo
Autore
Classe ‘98. Sono meridionalista, femminista e antifascista. Mi piace disegnare, scrivere e girare per musei. Ah, e ho una fissa per i film con protagonisti in crisi da quarto di secolo.