Quante volte siamo stati dietro una finestra appannata? A seguire le fughe di legno tra i vetri con il dito, ché tanto un po’ d’aria passa sempre. A osservare quella goccia di pioggia muoversi tremolante in un verticale discendere. Nascosti dentro i pensieri ovattati della nostra testa, vigili e attenti a non farci scoprire dall’esterno. Quante volte in preda a chissà quale congiunzione astrale tra Saturno e Venere abbiamo pensato: «Ma perché proprio a me?». Quante volte abbiamo puntato il dito contro un dolore tanto grande da schiacciare noi la voglia, la gioia, la curiosità, case libri auto viaggi fogli di giornale.
Beh, notiziona. Dostoevskij ci avrebbe detto: «Ma che te piagni?!». Vabbè, sì, forse con parole leggermente diverse, questo glielo concediamo. Però magari, chissà, se lo avessimo ascoltato, se lo avessimo saputo, a quest’ora avremmo sigillato qualche spiffero alla finestra, i vetri sarebbero limpidi e forse, voglio esagerare, ci sarebbe perfino uno spiraglio di sole.
Credo che chiunque, leggendo queste poche parole, abbia rivisto o intravisto tra una riga e l’altra la proiezione più sbiadita di sé, l’ologramma senza contorni definiti che è stato o che è ancora oggi. Dostoevskij lo è stato per una vita intera. Dostoevskij è uno di noi.
La sua vita non è di certo stata rose e fiori. Tutt’altro, direi: spine e crisantemi fin dall’inizio. E non è un caso che tutta la sua esistenza ruoti intorno ad un’ossessione: l’indagine sul e per l’uomo come essere umano. Indagine che inevitabilmente si ripercuote anche su se stesso. Ma anche un po’ su di noi. Sfido chiunque a non essersi guardato dentro almeno una volta nella vita. E comunque a non averci capito niente. Ma sorvoliamo, anche perché probabilmente Fëdor aveva capito qualcosa in più.
Immaginate una vita in cui sei figlio di un padre violento; rimani orfano di entrambi i genitori all’età di 18 anni; gli attacchi di epilessia ti tormentano, alternandosi ad un profondo senso di colpa che ti induce spesso ad un’autopunizione inconscia. Aggiungiamo un pizzico (o forse un barattolo) di vizio del gioco, una manciata di lavori forzati in Siberia dopo una condanna per cospirazione e la ricetta è completa. Ah no, scusate, ho dimenticato un probabile bipolarismo latente che si rispecchia nella sua continua ricerca della duplice natura dell’essere umano, in un dualismo costruito sui contrasti, i suoi. I nostri.
Questa era l’immagine riflessa allo specchio con cui Dostoevskij doveva fare i conti ogni mattina, appena alzato. Un’immagine dominata dall’angoscia, dal tormento interiore, da quell’inquietudine spirituale che racchiude in un solo uomo una combinazione di personalità contrastanti: un’inquietudine che sfocia in un’incolmabile tensione emotiva, donandoci pagine di elevata bellezza ed eleganza, seppur cariche di una malinconia liquida e sgusciante.
È facile immaginare l’autore chiuso nella sua stanza, i gomiti sul tavolo di legno scarno, le mani intrecciate sulla fronte, quasi a voler imprigionare per sempre tutta la sua sofferenza. Quasi a lottare per non farla uscire, invano.
Ed è proprio quando il suo dolore finalmente esplode, che Dostoevskij arriva ad una risposta straordinariamente folle: amare è la chiave di tutto. Perché «nonostante tutte le perdite e le privazioni che ho subito, io amo ardentemente la vita. […] Amo la vita per la vita».
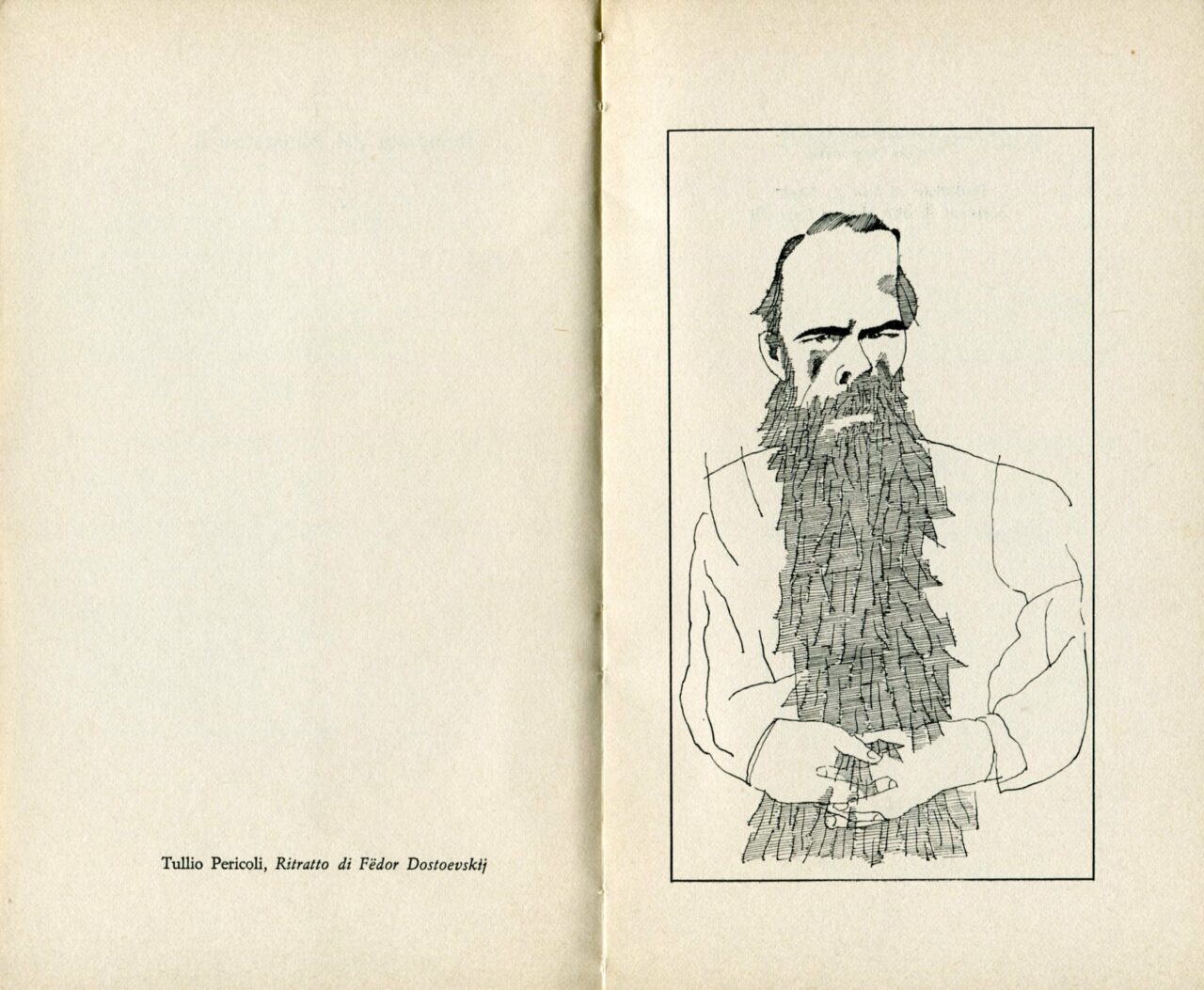
Dostoevskij è qui per ricordarci che anche nei momenti peggiori che pensiamo di non poter affrontare, nonostante tutta la sua negatività, nonostante la nostra, nonostante tutti i bastoni tra le ruote, noi esistiamo. «Io esisto, mi dibatto nella tortura, ma esisto! Sto legato al pilastro ma esisto pur sempre, vedo il sole, e se il sole non lo vedo, so che c’è. E saper che c’è il sole, è già tutta la vita». E quante volte ce lo dimentichiamo, che il sole c’è.
Che amare è la chiave per soffrire, ma che soffrire è la chiave per amare. E come potremmo mai apprezzare la vita senza aver conosciuto il dolore? Dante scriveva: «Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria». E, se ci pensiamo bene, è tutto qui, nella capacità di essere riconoscenti alla luce, solo dopo aver attraversato fondali bui.
Ma l’amore spassionato per la vita per Dostoevskij non è puramente astratto. Si riflette nell’amore per tre donne, Marija, Apollinarija e Anna, ma è anche il suo passepartout per giungere al divino, attraverso un cammino mediato dalla sofferenza: è solo affrontando il dolore che tu, uomo, giungerai alla redenzione. E qui, la parte religioso-filosofica del nostro autore sgomita per richiamare l’attenzione e rivelarci il suo segreto: scavare. Scavare quanto più possiamo in noi stessi, tenendo testa anche a ciò che non avremmo mai voluto vedere.
È nel capolavoro Le memorie del sottosuolo (1864) che l’uomo del sottosuolo è smarrito, disorientato, alla ricerca di qualcosa che illumini la sua esistenza. L’uomo del sottosuolo indaga se stesso e fa i conti con il mondo che ha dentro.
E noi? Sappiamo com’è fatto il nostro sottosuolo? È secco e arido perché all’aria viene impedito di entrare, oppure è umido di gocce salate che alimentano i germogli dell’inconscio?
E allora ecco quand’è il momento in cui dobbiamo leggere Dostoevskij: quando ci sentiamo a terra e respiriamo la disperazione. Allora, come diceva Hermann Hesse, «nel momento in cui, soli e paralizzati in mezzo allo squallore, volgiamo lo sguardo alla vita e non la comprendiamo nella sua splendida, selvaggia crudeltà e non ne vogliamo più sapere, allora, ecco, siamo maturi per la musica di questo terribile e magnifico poeta.»
E se è vero che la scrittura nasce da una mancanza, da un vuoto profondo o da una ferita, quella di Dostoevskij, nonostante la vediamo da un’altra prospettiva, non affonda il coltello nella piaga, né cerca di coprire il vuoto: lo scompone, lo indaga fino in fondo, lo cura e lo riporta ad un livello di reale tangibile.
Perché nonostante tutte le nostre Notti bianche, «succederà così anche a te. Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il sole, e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io sono sicuro. E presto. Anche domani».
E forse ognuno di noi avrebbe bisogno di un Dostoevskij nella vita, io il mio ce l’ho. Sul comodino, in alto a destra. Per ricordarci sempre di amare ancora, tutto l’amore che non abbiamo mai dato. E di accettare col sole tutto quello che non abbiamo ancora sofferto.
L’immagine di copertina è un’illustrazione di Veronica Leffe
Autore
Roma, classe ‘97. Era marzo e una cometa squarciava il cielo. Romantica nel senso ottocentesco del termine. A tratti crepuscolare, soprattutto quando piove. Attenta alle piccole cose, ai 33’ giri e ai giri a vuoto. Studio Editoria e Scrittura; quando non lo faccio leggo, sento, scrivo, penso (troppo), gioco con le parole. Non necessariamente in quest’ordine.







