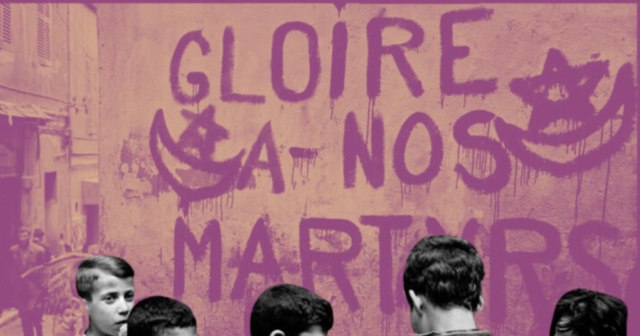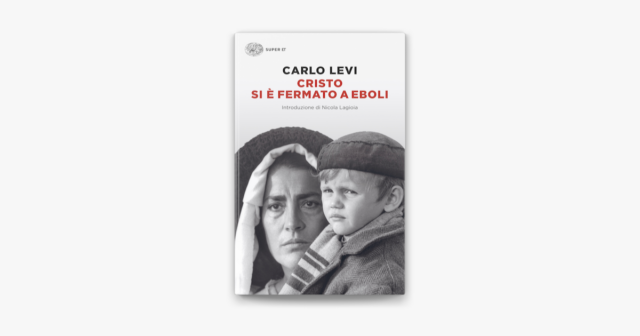Nel novembre del 1972, dal palco del Politeama Genovese, Giorgio Gaber cantava per la prima volta al pubblico delle strofe destinate a divenire manifesto musicale della sua visione politica e sociale: “La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un opinione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione”.
L’Italia, nel frattempo, stava entrando nel periodo più buio e sanguinoso degli anni di piombo, preceduto da anni di forte tensione politica, culminata nell’autunno caldo del 1968. Il cantautore milanese avvertiva i primi segnali di una deriva della coscienza collettiva socio-politica, che negli anni Settanta si mostrava già sterile, prona alla semplificazione ideologica e svuotata dei contenuti di dibattito democratico che l’avevano caratterizzata nel decennio precedente. Le piazze, da spazi pubblici colmi di dibattiti e comizi elettorali, diventeranno presto obiettivi terroristici e teatri di guerriglie civili. Una delle conseguenze di tale polarizzazione è proprio l’allontanamento di gran parte degli strati sociali dalla vita politica, che si fa quindi sterile, spettacolarizzata e minacciata dall’individualismo e dalle false stabilità diffuse dai populismi postmoderni.
Mezzo secolo più tardi, i versi di Gaber si traducono non più in ottica di conflitto o violenza politica, ma piuttosto di vacuità e indifferenza collettiva. Nelle nostre piazze gli eventi semplicemente non accadono, lo spazio pubblico è eroso dal silenzio, a sua volta cacofonia delle vite isolate di milioni di cittadini distratti. In un suo studio recentemente pubblicato, l’Istat osserva che negli ultimi 20 anni la partecipazione politica degli italiani è crollata dal 67% al 54% per gli uomini e dal 48% al 42% per le donne. Nel 2003, a partecipare ad almeno un corteo era il 6,8% dei cittadini, ad oggi invece circa il 3%.
Il dato più preoccupante, tuttavia, riguarda l’interesse politico tra i giovani: nella fascia d’età che va dai 18 ai 24 anni, sono più di un terzo i ragazzi che dichiarano di non informarsi di questioni politiche. Il fenomeno del declino del coinvolgimento non è locale, ma investe la maggior parte dei paesi occidentali, come dimostrato da un’importante ricerca condotta dalle università dell’Essex e di Montreal che, prendendo a campione 116 democrazie rappresentative, riscontra un calo medio di partecipazione elettorale dal 77% al 67% dalla fine degli anni Sessanta.
Anche qui, il peso maggiore è costituito dall’astensione degli under 30, i quali, generazione dopo generazione, risultano sempre meno presenti nella sfera politica. Un’ipotesi avanzata dai ricercatori dello studio citato è quella legata all’impatto che i sistemi socioeconomici delle democrazie occidentali hanno avuto sulla manipolazione dei valori civici nelle nuove generazioni. Nascere in un contesto dominato dalla globalizzazione e dal consumismo, infatti, condurrebbe le fasce più giovani a saper sempre meno riconoscere gli effetti pratici e locali delle scelte politiche, minando concetti di responsabilità individuale come la presenza elettorale, il dibattito e l’accesso all’informazione.
Negli stessi anni in cui Giorgio Gaber cantava la libertà come risultato della partecipazione collettiva, usciva l’edizione italiana della “Storia e critica dell’opinione pubblica”, pietra miliare del pensiero sociologico e politico contemporaneo in cui l’autore, Jurgen Habermas, concepisce l’idea di sfera pubblica. Questa, secondo il filosofo tedesco, sarebbe uno spazio di discussione intermedio tra la sfera privata e quella di Stato, dove i partecipanti non vincolati da alcun requisito di classe o ceto si riconoscono collettivamente come cittadini. La rilevanza di tale ambiente sta proprio nella sua informalità, nell’inclusività e nel libero accesso al dibattito e alle diverse visioni critiche dei singoli rispetto alla gestione statale della classe politica.
Tuttavia, con l’avvento dei mass media negli anni Cinquanta e il diffondersi dell’ultraliberismo negli anni Ottanta, Habermas afferma che tale sfera è stata gradualmente svuotata e soppiantata da logiche più astratte quali quelle dei mercati finanziari internazionali, del lobbying e del marketing politico. L’epoca contemporanea, quindi, è caratterizzata da quelle che sono sfere pseudo-pubbliche, ovvero spazi all’apparenza ancora aperti e democratici in cui l’individuo perde progressivamente facoltà di osservare criticamente la realtà circostante, divenendo semplice spettatore passivo e consumatore di slogan, finzioni televisive e interazioni funzionali allo status quo economico.
Anche le nuove piazze digitali, seppur preziosi strumenti di informazione gratuita e di libero scambio di opinioni, rischiano di soccombere a logiche di manipolazione e di persuasione da parte dei gruppi politici e imprenditoriali che le controllano al fine ottenere una semplice attenzione transitoria, effimera e monetizzabile.
La crisi della partecipazione che le società stanno vivendo, si rivela quindi una crisi esistenziale ed intergenerazionale legata alla definizione di ruolo del cittadino: un elemento cardine della società che rischia di essere un mero consumatore di messaggi preconfezionati e distribuiti da entità politiche sempre più lontane e impercettibili. Per non sprofondare nel vuoto dell’indifferenza o, ancor peggio, di una partecipazione politica istintuale, violenta e polarizzata, è necessario ricostituire il concetto di individuo come attore critico di una realtà collettiva fondata sulla comunicazione informata che non sia definita dagli organi di potere ma piuttosto che sia diretta ad essi.