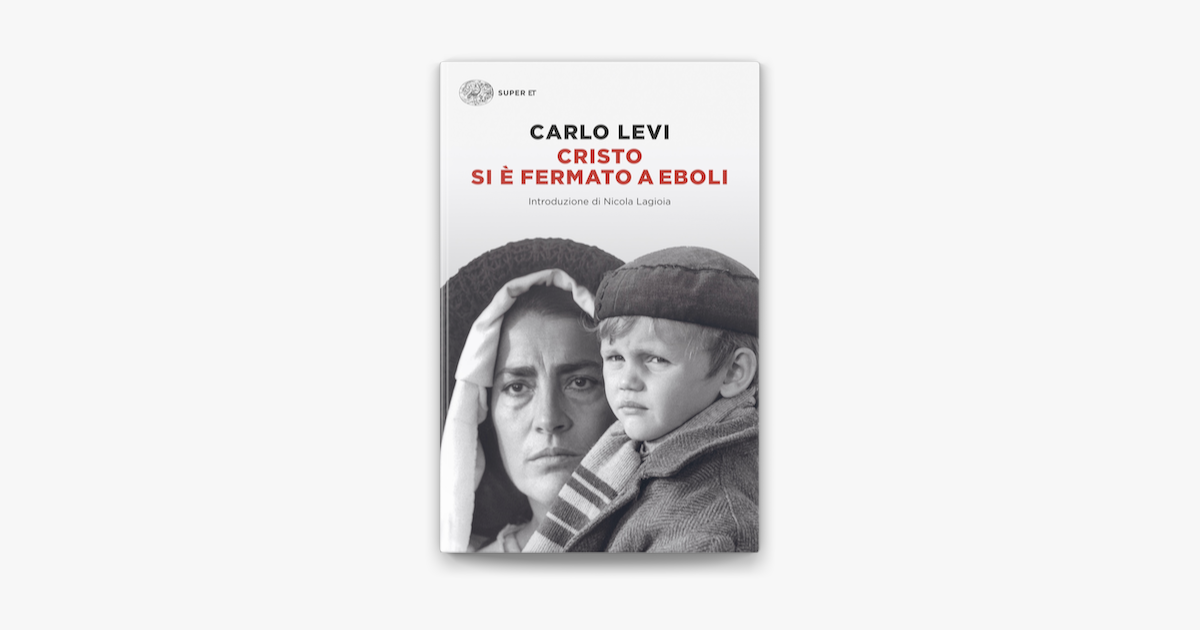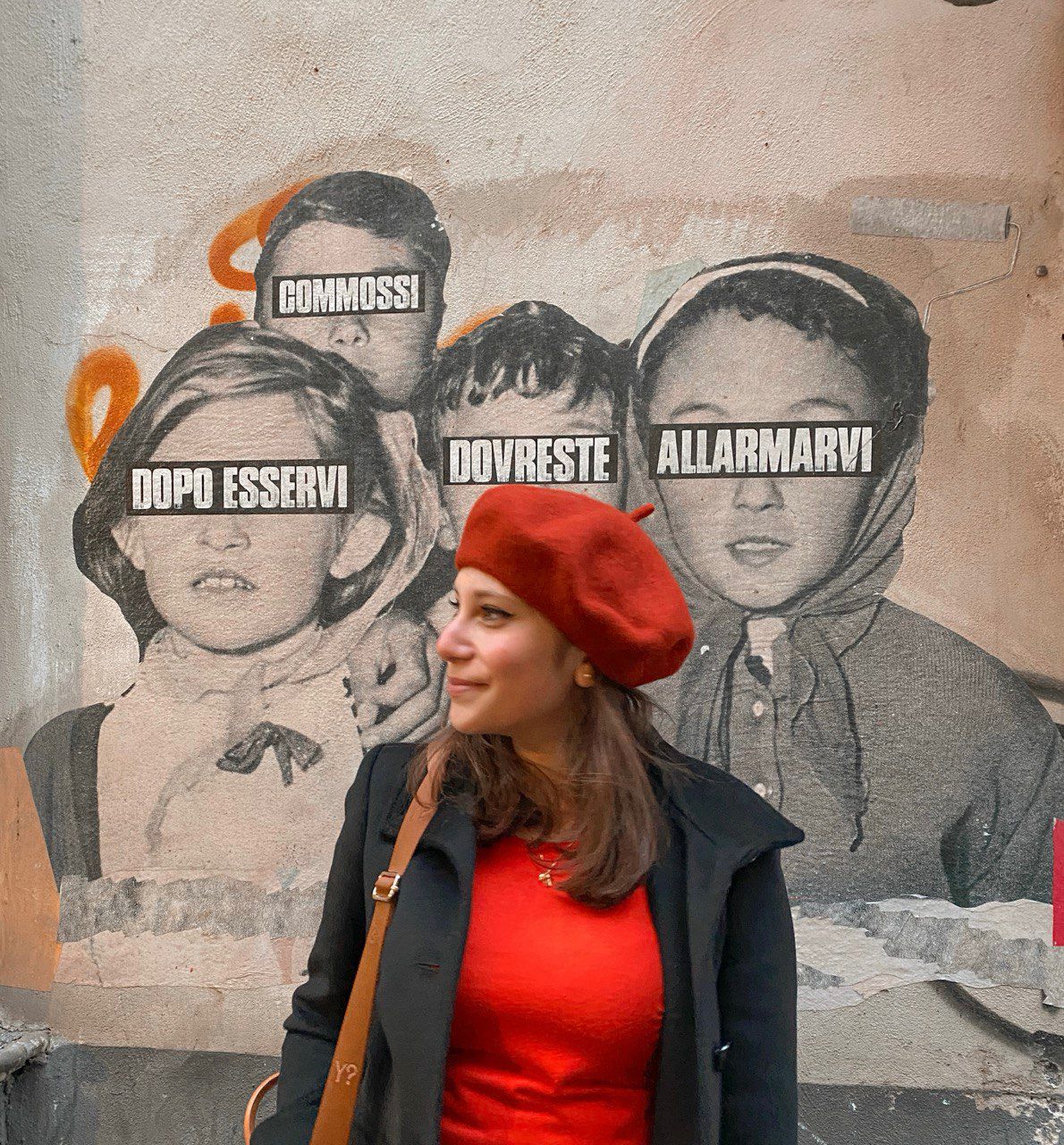Sono trascorsi esattamente ottant’anni dalla pubblicazione di Cristo si è fermato ad Eboli (edito per la prima volta da Einaudi, nel 1945), il romanzo in cui il piemontese Carlo Levi riflette sulla situazione di arretratezza e immobilismo del meridione della prima metà del Novecento, provando a ripercorrere le cause e ad azzardare possibili soluzioni. In quest’opera, Levi descrive la sua esperienza da intellettuale esiliato nell’entroterra Lucano, (ri)scopre la questione meridionale denunciando le condizioni di miseria e sottosviluppo che i contadini del Sud Italia hanno dovuto scontare.
Nel 1935 Levi – medico non praticante e pittore affermato – viene confinato, prima a Grassano e poi ad Aliano (in Basilicata), per via delle sue posizioni apertamente socialiste ed antifasciste. Qui ha modo di osservare da vicino un mondo totalmente diverso da quello da cui proviene, un mondo immobile, fuori dal tempo, dalla storia e soprattutto in totale contrasto con la moderna società borghese. Trascorrendo un anno insieme ai braccianti lucani, impara a conoscere le esigenze di un’Italia diversa dalla sua, contraddistinta da un carattere rurale, da tradizioni quasi pagane e schiacciata da una ristretta borghesia parassitaria che reprime qualunque tentativo di riscatto. Con questo romanzo, Levi contribuisce soprattutto a creare una prima vera polarizzazione della questione meridionale: egli, infatti, sottolinea con durezza le responsabilità della ricca classe dirigenziale locale – quasi sempre in combutta col potere fascista – nei confronti della stragrande maggioranza della popolazione che vive invece in totale miseria. Una povertà imputabile, agli occhi della realtà contadina, anche allo Stato unitario, visto come elemento astratto e indifferente ai veri problemi delle periferie del Sud e, per tale motivo, da non riconoscere.
Tuttavia, oltre alla rassegnazione o ai piccoli e fallimentari tentativi di emigrazione, Levi scorge nelle masse popolari della periferica Basilicata una “potenziale forza storica determinante”, come l’avrebbe definita Calvino più tardi.
Si tratta, cioè, di una latente aspirazione al cambiamento che viene però repressa a causa della mancanza di consapevolezza e dei giusti strumenti culturali. Ed è proprio in virtù di queste convinzioni che lo scrittore arriva a proposte di stampo federalista per risolvere la questione meridionale, sfociando in concenzioni autonomiste non sempre sostenute dall’ambiente di sinistra in cui orbitava. Lo stesso Mario Alicata – critico letterario e partigiano calabrese – non approva questa soluzione. Sebbene riconosca il grande lavoro svolto nel Cristo, Alicata sostiene anche il limite di Levi sia dato da “l’enunciazione di una serie di tesi senza consistenza teorica, nelle quali si rivela chiaramente come [l’autore] sia estraneo ad ogni proposito di spiegare storicisticamente le ragioni dell’inferiorità sociale del Mezzogiorno” (come scrive ne Il meridionalismo non si può fermare a Eboli in “Cronache Meridionali”).
Alicata riconosce a Levi il merito di aver riaperto il dibattito sulla questione meridionale e di aver parlato del contrasto esistente tra le due Italie, tra il centro e la periferia rurale ma, allo stesso tempo, non concorda sulle modalità risolutive proposte dall’intellettuale torinese, poiché sono viste alla stregua di “una spiegazione metafisica, misticheggiante, alla ipostatizzazione delle ‘entità’ campagna e delle ‘entità’ città”. Inoltre, per Alicata è controproducente far fede unicamente sulle forze dei contadini meridionali dato che, non riconoscendo appieno lo stato in cui si trovano, si finirebbe con molta probabilità a fomentare una guerra civile che li vedrebbe inevitabilmente sconfitti. Dunque, alla rivoluzione contadina di cui Carlo Levi si faceva profeta, Alicata si oppone con convinzione, trovandosi più in linea con le posizioni di stampo gramsciano, che vedono come unica via d’uscita lo sviluppo di un movimento popolare che coinvolga non solo i contadini ma anche la classe media e gli intellettuali di tutto il Sud e che, in particolar modo: “comprenda l’esigenza dell’alleanza con la classe operaia e ne accetti la direzione”.
Dopo ottant’anni dalla pubblicazione del capolavoro leviano – e dall’insorgenza di numerosi dibattiti – sarebbe il caso di dire che, non solo non si è realizzato nessuno dei vari pronostici, ma non si è neppure riusciti a colmare quello scarto socio-economico tra meridione e settentrione che da sempre attanaglia la politica della nostra nazione. Sebbene nel 1972 i maggiori giornali annunciavano che il divario sarebbe stato colmato solo nel 2020 (come dimenticare i numerosi post su instagram di qualche anno fa con la prima pagina del Corriere della Sera e il titolo della notizia scritto a caratteri cubitali) oggi si può constatare come nulla di tutto questo sia avvenuto. Qualche piccolo cambiamento c’è stato, ma i problemi principali sono rimasti invariati o, in alcuni casi, addirittura aumentati.
Tra essi, rientra la questione occupazionale che, nonostante i lievi incrementi degli ultimi anni (nel 2024 si è registrata una crescita occupazionale del +2,2% a fronte del +1% al Nord e del +1,9% al Centro), rimane comunque critica. Difatti, più della metà del numero totale di disoccupati, per la fascia d’età tra 15 e 64 anni, è concentrata nel Mezzogiorno. Il problema della mancanza di lavoro è sempre stato cruciale per il sud ed è sempre stata una delle cause primarie del flusso migratorio, cominciato nell’Italia post bellica e intensificato nei periodi di industrializzazione del Nord. Il problema degli spostamenti massicci dal Sud verso il Nord o l’estero persiste ancora oggi, con l’unica differenza che ad andarsene non sono più solo gli operai, la forza lavoro manuale, ma anche e soprattutto quella intellettuale. Negli ultimi vent’anni, i meridionali laureati che partivano per il settentrione erano circa il 26%, dato in notevole aumento dal 2022 in quanto, su 63 mila giovani emigrati, ben il 42% è in possesso di un titolo di studio universitario. Nello stesso arco di tempo più di un milione di persone ha lasciato la propria regione e – stando ai dati Svimez dello scorso anno – entro il 2080 la popolazione sotto il Lazio scenderà di 8 milioni di residenti, arrivando alla metà degli abitanti attuali.
I motivi di tale esodo non sono però riconducibili solo alla crisi occupazionale, ma anche ai pochi e mal gestiti servizi pubblici. La spesa pubblica sanitaria, per esempio, è minore rispetto alle zone centrali e settentrionali: è ridotto il numero degli ospedali (molti dei quali chiusi o privatizzati), così come i servizi di prevenzione – anche oncologica – spingendo chi può permetterselo a spostarsi per curarsi. Un discorso analogo riguarda l’istruzione: al meridione il tasso di dispersione scolastico è nettamente maggiore (nel biennio 2022/23 la platea studentesca si è ridotta del 9% al sud contro il 4% del centro-nord), per non parlare del minore investimento nelle strutture educative. A questo si aggiunge l’annoso problema dei trasporti e delle infrastrutture: ci sono poche ferrovie e spesso ad un solo binario, l’Alta Velocità arriva solo in Campania, mentre servizi come tram e metro per i grandi centri urbani sono praticamente inesistenti.
Se nel 1945 per Carlo Levi la civiltà si fermava “dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare, e si addentrano nelle desolate terre di Lucania” oggi, quasi un secolo dopo, la questione meridionale sembra esser rimasta ferma ad Eboli.
Autore
Rachele Liuzzo
Autore
Classe ‘98. Sono meridionalista, femminista e antifascista. Mi piace disegnare, scrivere e girare per musei. Ah, e ho una fissa per i film con protagonisti in crisi da quarto di secolo.