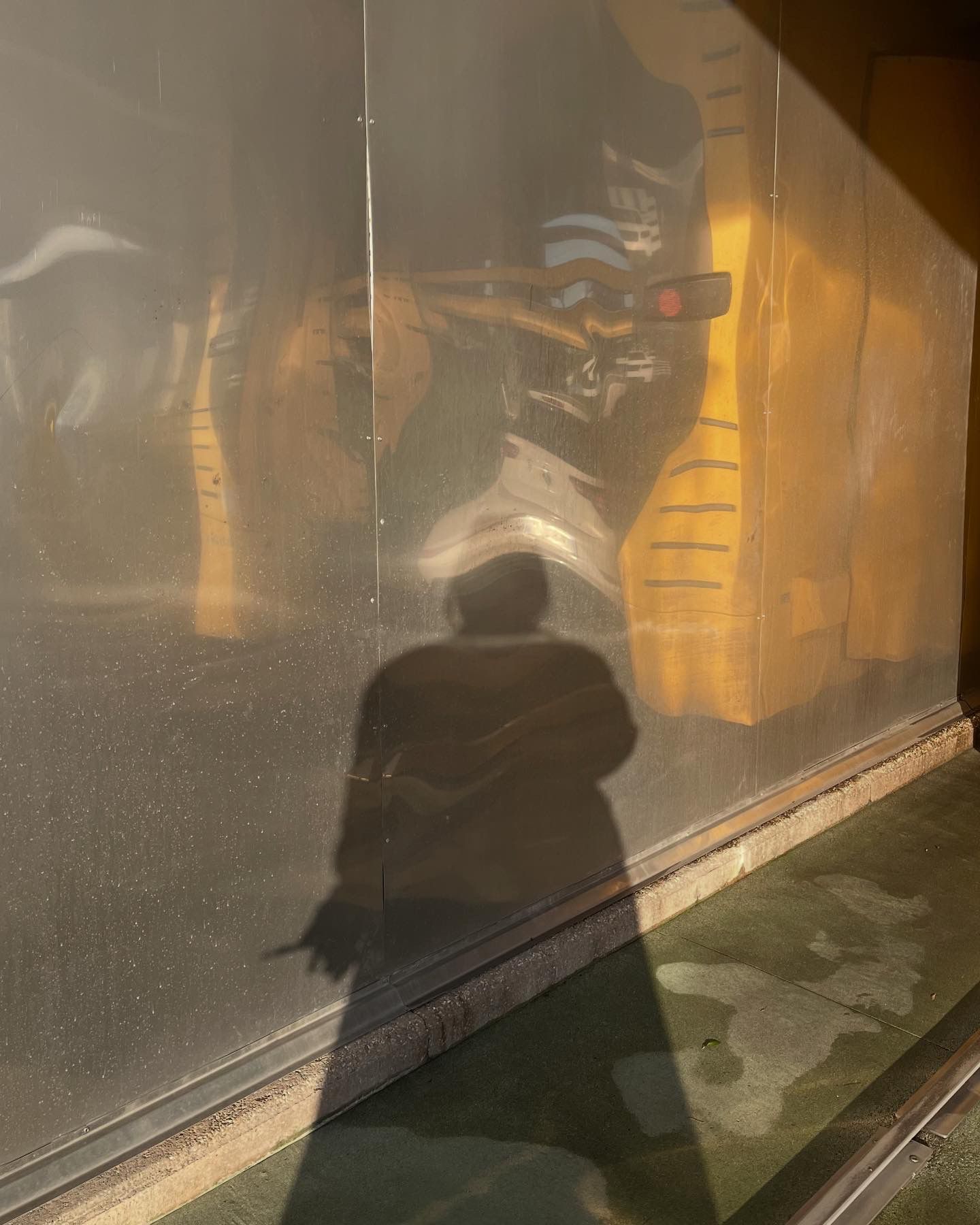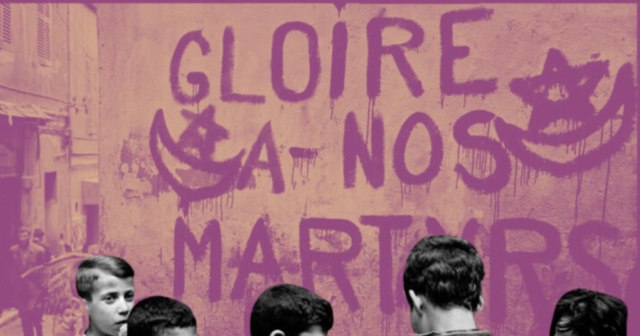Lo scorso sabato 18 ottobre mi sono diretta verso il raduno convocato dal Collettivo di Fabbrica ex GKN con un po’ di timore. E non per la piazza in sé o i suoi possibili epiloghi, ma per quel silenzio che spesso segue la fatica, quando la resistenza si logora nel tempo. Dopo quattro anni di presidio, di riunioni, di lavoro quotidiano, mi chiedevo se fosse ancora possibile mantenere la stessa intensità, la stessa presenza collettiva che ha reso questa lotta un punto di riferimento.
È bastato poco per capire che quella preoccupazione fosse infondata. Firenze è stata attraversata da una moltitudine di diecimila persone. È stato un corteo ampio, vivo, in cui la convergenza delle lotte era visibile e concreta. Le strade risuonavano di cori, tamburi, grida. Due carri sonori, uno della rete dei Collettivi Wish Parade, l’altro dell’aggregato Esplodiamo insieme al Comitato 25 Aprile di Prato, hanno accompagnato la manifestazione con suoni che si intrecciavano ai passi di chi avanzava. Quella pluralità non era solo estetica o numerica, era una trama politica fatta di provenienze e pratiche diverse che, per un giorno, hanno trovato un ritmo comune. C’erano operai/e, studenti/esse, attiviste/i ambientali, collettivi transfemministi, persone del territorio e non, cittadine e cittadini. In quel movimento condiviso si riconosceva e sentiva che le lotte, per quanto differenti, possono procedere fianco a fianco, andando e tornando insieme. Che fosse attraverso un coro, uno striscione, una sfilata sonora o un cartello, eravamo tutte lì, presenti, consapevoli, determinate a non arretrare. Pronte a tenere la testa alta di fronte a quel Golia che ambisce alla nostra resa.
Mi sono resa conto che il timore di trovarmi davanti a un requiem nasceva dal mio stesso rapporto con questa storia. Per me la lotta del Collettivo di Fabbrica è importante perché interroga la mia idea di politica, di comunità, di futuro. Ed è questo il segreto della loro resistenza, l’aver creato un pezzo di “noi” superando l’essere solamente “loro”.
In quelle strade si è gridato contro la chiusura del possibile, non solo di una fabbrica.

Ma facciamo un passo indietro. Nella periferia di Firenze c’è un luogo in cui da quattro anni si prova a cambiare il senso stesso della parola “lotta”. Chi conosce quella zona sa quanto sia a tratti estraniante. Un classico centro commerciale di provincia domina sulla visuale e sulle interazioni. Eppure, in questa estraniazione, negli ultimi anni è successo qualcosa che segna un punto di rottura per tutte e tutti. L’ex stabilimento GKN di Campi Bisenzio è diventato qualcosa di più di un simbolo, è un laboratorio di metodo, una pratica di realtà che prova a riscrivere il vocabolario della politica, del lavoro, dell’immaginazione collettiva. Da quattro anni, lì, si prova a capire cosa significhi davvero pensare un futuro diverso, che non sia soltanto proiezione o sogno, ma costruzione quotidiana ed esercizio costante.
Nel luglio del 2021, la GKN (multinazionale britannica) ha annunciato la chiusura dello stabilimento, e il conseguente licenziamento di centinaia di lavoratori e lavoratrici, con un’e-mail. La storia, per come ci viene raccontata, sarebbe dovuta finire lì. Un’altra fabbrica chiusa, un’altra comunità smantellata, un’altra pagina di cronaca industriale. Invece è successo qualcosa di anomalo. Le persone, invece di disperdersi, sono rimaste. Hanno aperto i cancelli, si sono riunite, hanno deciso di non lasciare che la loro storia venisse raccontata da altri. Il Collettivo di Fabbrica GKN ha risposto con l’organizzazione, capovolgendo la grammatica della sconfitta, facendo della continuità il proprio strumento politico, della comunicazione una forma di costruzione, della cooperazione la materia di un nuovo possibile. In un tempo che ci vuole far credere di non avere alternative, loro stanno provando a costruirne una, con metodo.
La prima lezione che ci consegnano è la presenza costante. In questi anni la fabbrica non è stata abbandonata un solo giorno. Presidi, assemblee, eventi. Una vita collettiva che ha sostituito l’inerzia della dismissione con la regolarità del gesto. Essere lì fisicamente ha significato molto più che resistere, perché ha impedito concretamente la cancellazione. Ogni giorno trascorso dentro quello spazio è stato, ed è, un atto politico, una negazione dell’oblio. La lotta ha assunto la forma della quotidianità, e in quella durata ha trovato la propria credibilità.
La seconda lezione riguarda il linguaggio. Il Collettivo ha compreso che nessuna lotta sopravvive se non si racconta. Non nel senso pubblicitario del termine, ma come costruzione di senso condiviso. “Insorgiamo” è diventata una pratica comune, un verbo collettivo. Raccontarsi per loro non è un esercizio di visibilità, ma un modo di tenere insieme mondi diversi. Operai/e, attivisti/e, studenti/esse, cittadini/e, ambientalisti/e. Hanno scritto, parlato, filmato la propria storia senza mai separarla dalla realtà materiale della fabbrica. In questi anni il Collettivo ha prodotto un linguaggio che parla di cooperazione e responsabilità tangibile.
La terza è la costruzione concreta, che per il Collettivo di Fabbrica non è soltanto un piano industriale alternativo o un progetto di riconversione ecologica, è una forma di pensiero che vive nella complessità. Ogni discussione, ogni scelta collettiva è attraversata da molteplici tensioni, tra il bisogno di resistere e la necessità di progettare, tra la tecnica e l’immaginazione, tra l’urgenza ecologica e la giustizia sociale. In questo intreccio, il Collettivo ha imparato che costruire significa abitare le contraddizioni senza ridurle, imparare a sostare nella complessità invece di semplificarla. La convergenza di cui tanto si parla, qui, non è retorica, è materia viva di lavoro politico. È in questa capacità di articolare il complesso che risiede la forza del Collettivo, perché si radica nella capacità di trasformare la crisi in infrastruttura, dove costruire, quindi, diventa una forma di intelligenza collettiva che non fugge la complessità, perché vuole attraversarla, organizzarla, renderla porosa.
Da questi anni di confronto e fare è nata una cooperativa, GFF (GKN For Future), sostenuta popolarmente, simbolo di una nuova forma di azionariato diffuso. La fabbrica, così, diventa un bene comune, attraversata da una pluralità di soggetti che la fanno vivere, in una pratica di democrazia produttiva. Tutto questo accade in un contesto di resistenza istituzionale feroce. Ogni passo avanti viene ostacolato da procedure, silenzi, burocrazie. I poteri pubblici oscillano tra simpatia retorica e immobilità fattuale.
Quella in corso è una battaglia contro un sistema che preferisce la morte lenta alla trasformazione. È una guerra fredda amministrativa, fatta di ritardi, omissioni, cavilli che consumano il tempo e le energie di chi prova a costruire un futuro diverso. Ma proprio in questo conflitto, la formula di GKN si fa ancora più chiara: il cambiamento non si delega e non si attende dall’alto, si costruisce nel fare, nel coordinare, nel condividere. Il loro metodo è una pratica che dovremmo, dobbiamo, moltiplicare. Il Collettivo ha tenuto insieme forze che altrove restano divise in una pratica che è intersezionale in senso concreto, perché si muove nel punto in cui i conflitti si incontrano. È una sfida che riguarda tutte e tutti, perché tocca la radice della parola “produzione”, ciò che mettiamo nel mondo. Quello che ormai è cristallino davanti a noi è che ogni forma di potere cerca di chiudere il possibile e, conseguentemente, ogni atto di soggettivazione collettiva lo riapre. È da questo punto di vista, da questa breccia, che nel totale silenzio che riempie le stanze di potere sullo sblocco della situazione, dobbiamo cogliere ciò che nelle nostre mani può essere strumento: ogni parte di questa esperienza è pensata per essere replicabile.
Spostare il possibile. Non dichiararlo, ma produrlo.
Forse ciò che emerge, qui, è una diversa idea di costruzione politica, più vicina a una pratica di composizione che a un gesto di conquista. Si tratta di tenere insieme ciò che il potere separa, rimanere nel tempo di mezzo che si crea tra la distruzione e la possibilità, e renderlo abitabile. La lotta allora torna a essere una forma di apprendimento collettivo. Ogni volta che una comunità organizza il proprio tempo e i propri limiti, costruisce una competenza politica che nessuna istituzione insegna, quella della permanenza. Nella stanchezza, nella fatica che drena, ogni esperienza collettiva che resiste al logoramento istituzionale produce una verità semplice e radicale, ovvero che la politica non coincide con la decisione, ma con la cura. Perché costruire diventa un atto di mantenimento reciproco, un modo di non cedere all’intermittenza. Perché ogni volta che qualcuno tiene aperto uno spazio, che sia una fabbrica, un’assemblea, una scuola occupata, non difende solo ciò che esiste, ma custodisce la possibilità di un’altra misura del tempo.
La fabbrica oggi è un organismo politico e sociale, un punto di riferimento per chi cerca una nuova grammatica della trasformazione. In un panorama in cui la politica istituzionale appare incapace di produrre senso, GKN ci mostra che la democrazia può ancora nascere dal basso, dentro le relazioni di lavoro, nei luoghi abbandonati dal mercato e dalla burocrazia; che la continuità è forza costituente. Ciò che accade lì non è nostalgia operaia né utopia. È metodo. Un metodo che parte dal riconoscimento della propria posizione e la trasforma in piattaforma collettiva e intelligenza condivisa. Quella messa in atto dal Collettivo è la pratica di un futuro costruito giorno dopo giorno, senza nessuna garanzia e con molti ostacoli, ma con un principio chiaro: la collettività è la sola infrastruttura che resiste al collasso del mondo. Ecco perché GKN non è soltanto una vertenza. GKN è una scuola. Ci insegna che il cambiamento non è mai una questione di grandezza, ma piuttosto di densità, e che le alternative non si dichiarano, si dibattono e costruiscono.
Da quando questa storia è iniziata, le piazze si sono riempite e i corpi si sono mossi nello spazio scanditi dai tamburi, una domanda mi tormenta: cosa accadrebbe se questo modo di stare venisse replicato? Se ogni comunità, grande o piccola, provasse a fare lo stesso?
Certo, probabilmente non basterebbe a rovesciare il sistema, ma basterebbe a scardinarne l’inevitabilità.



Autore
Martina Maccianti
Autrice
Martina Maccianti scrive per decifrare contemporaneità e futuro. Tra linguaggio, desiderio e utopie, esplora nuove visioni del mondo, cercando spazi di esistenza alternativi e possibili. Ha scritto per le riviste L’Indiscreto, The Bunker, In allarmata radura. Nel 2022 ha fondato un progetto di pensiero e divulgazione chiamato Fucina.